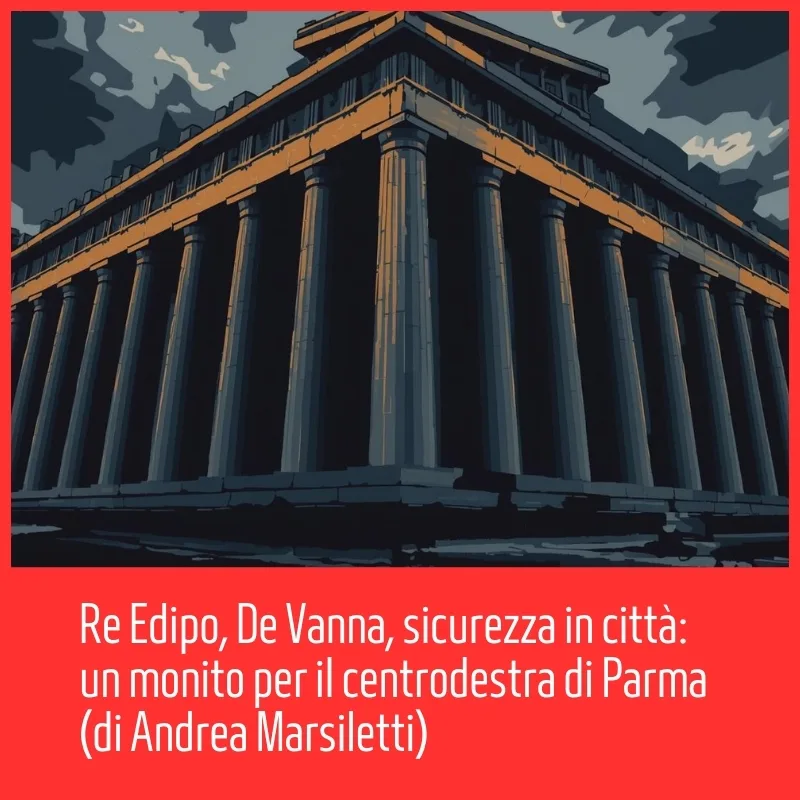di Tommaso Villani
Gian Maria Tosatti è riconosciuto a livello mondiale come uno degli artisti più originali e profondi della scena contemporanea. Il suo nome si pronuncia accanto a quello di grandi protagonisti dell’arte internazionale, eppure, nonostante sia nato a Roma e la sua carriera lo porti a viaggiare incessantemente tra continenti, nel cuore conserva una passione che parla di casa, di radici autentiche: è da sempre tifoso del Parma Calcio.
Per Tosatti, il legame con Parma è molto più che un semplice interesse sportivo. Ama tornare nel capoluogo emiliano per respirare l’atmosfera dello stadio, per riassaporare i sapori genuini della cucina locale — un piatto di tortelli di erbetta, due fette di prosciutto crudo — e ritrovare quella fede sportiva che lo accompagna fin da ragazzo. Questa passione privata, sincera e sentita, convive armoniosamente con l’artista impegnato nel suo percorso globale, che vede l’arte come uno strumento di conoscenza e trasformazione sociale.
La passione per il Parma Calcio nasce in ritardo: «Sono cresciuto in una famiglia di sole donne. Per cui, da bambino, nessuno mi portava allo stadio o mi faceva scegliere una fede magari per una delle due compagini capitoline. Così, a undici anni, quando giunsi alle scuole medie, iniziai a guardare la Serie A. Fu uno spettacolo inedito, e meraviglioso. E in quella scena si imponeva una squadra di provincia da poco sotto i riflettori: il Parma di Nevio Scala (nome da poeta dell’antichità e pratica da poeta del calcio contemporaneo)».
Fu amore a prima vista: «Venni folgorato. Quei giocatori avevano qualcosa di speciale allora, un’altra energia. E negli anni lo hanno dimostrato. Non dimentichiamoci che per un decennio la nostra nazionale era a trazione Parma. In difesa specialmente: Benarrivo, Mussi, Minotti, Apolloni…».
Il Parma più bello, però, arriverà secondo l’artista, qualche anno dopo: «Premesso che considero Gianfranco Zola il più grande giocatore che abbia mai visto — certamente per le doti tecniche, ma anche per le irraggiungibili qualità umane — il miglior Parma che ho visto giocare è stato probabilmente quello di Malesani. Quella squadra sembrava la versione calcistica degli Harlem Globetrotters. Era fantasia al potere. Due esterni destri di centrocampo, un fantasista come Veron e due veri mostri in attacco come Crespo e Chiesa. Forse, in quel momento, era la squadra più bella del mondo. Magari non era la più solida, ma chissenefrega. A me il calcio piace vederlo giocare: meglio perdere brillando che vincere col catenaccio. Il calcio è cuore e bellezza. È una danza, come nel film di John Huston, Fuga per la vittoria. Fare i calcoli è una cosa meschina, esattamente come nell’arte».
Il momento attuale è meno brillante rispetto al passato, però: «Oggi c’è una società diversa. All’epoca c’erano enormi capitali. Ma non è importante. Nel calcio moderno mi pare che il cuore stia tornando a contare molto. E mi pare che questa squadra, cuore, ne abbia. Il presidente Krause — che, purtroppo, non conosco personalmente — so essere un appassionato d’arte contemporanea. C’è da sperare che la pensi come me sulla qualità del gioco: guardiamo alla bellezza. Facciamo divertire i tifosi».
Il 4 e 5 novembre Tosatti inaugurerà la 24ª edizione della Bienal de Arte Paiz, tra Città del Guatemala e Antigua, una delle rassegne più prestigiose e durature dell’America Latina. La mostra, intitolata El árbol del mundo, resterà aperta fino al 15 febbraio 2026, e vedrà la partecipazione di quarantasei artisti internazionali di grande rilievo: da Oscar Murillo ad Ana Gallardo, passando per Kader Attia e il Leone d’Argento Ali Cherri. Tra gli italiani presenti, oltre a Tosatti, figurano Diego Cibelli e Adji Dieye.
Per Tosatti, prendere parte a questa biennale rappresenta molto più di un semplice momento espositivo. È un confronto profondo con un ecosistema artistico e sociale radicalmente diverso, ma sorprendentemente affine nelle tensioni poetiche e nelle urgenze condivise. Le sue opere, da sempre radicate nel contesto e nella memoria collettiva, trovano qui un terreno particolarmente fertile, frutto di un lavoro lungo e intenso.
L’artista ha trascorso un anno in Guatemala, immergendosi nelle comunità più fragili, ascoltando storie di abusi, sogni e violenza. Racconta di aver vissuto in hotel frequentati da persone segnate dalla sofferenza, di essersi perso lungo strade percorse da cani randagi, testimoni silenziosi di un dolore spesso ignorato. Ma in questa durezza, Tosatti ha cercato la luce, «l’ultima goccia di splendore», come direbbe Álvaro Mutis: un barlume capace di non far morire l’albero del mondo.
Nel segno di Eugenio Viola, curatore della biennale e già al timone del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2022, Tosatti ha scelto la pittura — la forma artistica più antica e insieme più essenziale — per esprimere l’intensità emotiva del presente. Le parole di alcune tessitrici guatemalteche — «i tessuti sono la letteratura del nostro Paese» — riecheggiano nel suo dipinto, intrecciando la storia europea con quella del Sud globale, portando alla luce voci spesso silenziate e invitando a una riflessione sul diritto a una giustizia e a una distribuzione equa delle risorse.
E mentre Tosatti costruisce installazioni in giro per il mondo, il suo amore per Parma rimane saldo. Tornare in città, assistere a una partita dei crociati, vivere quei momenti di normalità e comunità è per lui un ancoraggio prezioso. Perché anche chi plasma nuovi mondi con l’arte ha bisogno di un luogo da cui tutto è partito, di una passione che non cambia e si rinnova di anno in anno.
Gian Maria Tosatti non è solo un artista di fama internazionale, ma una figura quasi sciamanica, capace di trasformare il dolore collettivo in memoria viva, visione rinnovata e stimolo al cambiamento. Il suo lavoro è un atto di cura estetica e politica, che illumina le tenebre con la speranza di un futuro più giusto, senza mai dimenticare le radici profonde e il cuore che batte forte per Parma.
Foto di Michele Stanzione