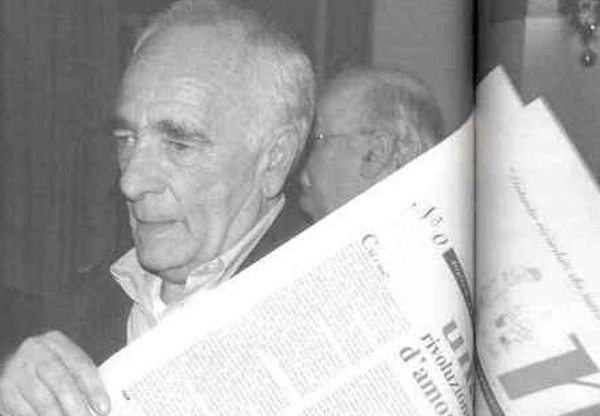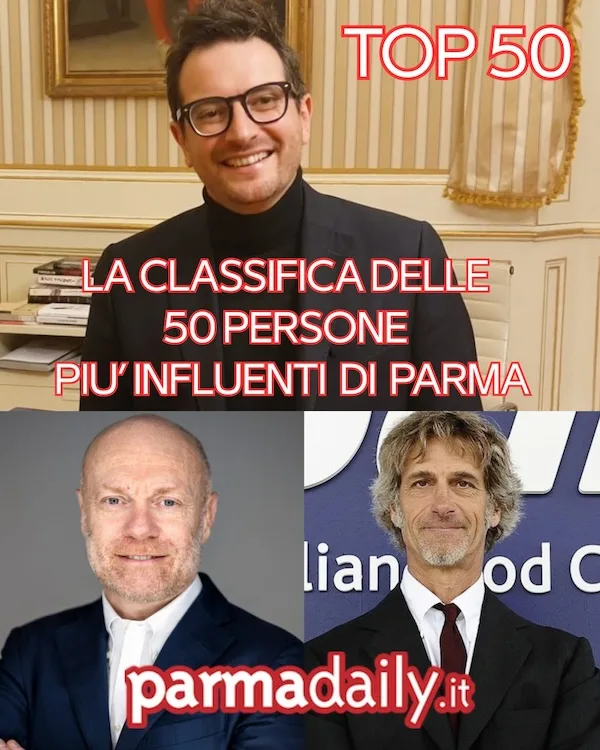In fondo tutto comincia da là, dal Panopticon, il carcere ideale progettato dal filosofo inglese Jeremy Bentham, alla fine del ‘700: “osservare tutti”, senza permettere a nessuno di capire se si è osservati.
Così, si potrebbe dire, tutto finisce qua: la triste vicenda del carcere di Santa Maria Capua a Vetere viene svelata proprio dai cento occhi del gigante Argo, le videocamere.
Il povero Bentham non avrebbe di certo mai immaginato che il suo carcere avrebbe subito una nemesi così esplicita, ma già il concetto di “istituzione totale” stava alla base della sua visione sociale, dove i soggetti pericolosi ma anche i sorveglianti sono l’istituzione totale, gli uni per imposizione, gli altri per scelta.
Una visione sociale che si è imposta e ha percorso i secoli adeguandosi solo tecnologicamente mentre l’ideologia sussistente, come ha insegnato Michel Foucault, rimane la stessa: sorvegliare e punire.
Sì, perché il “sovraffollamento”, cronico problema delle carceri italiane, non ha nessuna relazione con la “repressione”. Il sorvegliante non ha alcuna ragione nel diventare aguzzino a causa dell’esubero di ospiti.
Al contrario, dovrebbe solidarizzare con la controparte, per migliorare le condizioni degli istituti penitenziari. La punizione è, quindi, una “regola del gioco”, non una anomalia. L’eccezione probabilmente è il pestaggio sistematico e organizzato mentre la punizione rimane lo strumento fondamentale, che regola la relazione sorvegliante-sorvegliato.
Per il Ministero della Giustizia la straripante situazione carceraria è rappresentata da due dati: 50.779 posti regolamentari occupati da 53.637 detenuti. Ma il 5,6% in più della popolazione carceraria può definirsi sovraffollamento?
Allora il problema dove sta? Dalla stessa fonte, si legge che in Emilia Romagna ci sono solo 254 detenuti eccedenti lo spazio regolamentare, mentre da un recente servizio televisivo nel programma DataRoom di Milena Gabanelli, risulta che, solo a Bologna, sono 244 i detenuti in esubero rispetto agli spazi disponibili.
Sorvegliare. Nel 2011, una circolare dell’Amministrazione Penitenziaria istituisce i colori per indicare la pericolosità dei carcerati: bianco, verde, giallo e rosso. I codici a colori vengono poi abbandonati nel 2015, quando un’altra circolare istituisce l’autogestione all’interno delle sezioni carcerarie (gli agenti rimangono fuori dai bracci per 8 e 14 ore al giorno). Ovviamente queste inutili disposizioni non hanno alcun impatto nel miglioramento del regime di vita carcerario; mostrano invece con quale approssimazione e disinteresse la questione venga governata.
Punire. Nel 2017, con la legge n. 110, dopo innumerevoli richiami dell’UE, l’Italia introduce il reato di “tortura”. A Torino vengono denunciati, dalla Garante comunale delle persone private della libertà e dal Garante Nazionale, venticinque agenti, indagati per tortura conseguenti a fatti risalenti al 2017.
A Palermo nel gennaio 2020 un esposto denuncia alcuni agenti penitenziari per tortura e i medici del carcere, per non avere accertato le lesioni a danno di detenuti. A marzo 2020, viene presentato un esposto per tortura sia al carcere di Opera a Milano sia al carcere di Melfi, a seguito dei maltrattamenti e degli abusi adottati contro i detenuti in rivolta per il diffondersi del Covid-19. Il mese successivo è il turno di Pavia, con una denuncia per tortura nel suo carcere per violenze e abusi a seguito di proteste.
Il 15 gennaio 2021 a Ferrara per la prima volta un agente di polizia penitenziaria viene condannato a tre anni di reclusione per tortura inflitta a una persona detenuta. I fatti risalgono al 2017. Il 17 febbraio 2021 dieci agenti di polizia penitenziaria del carcere di San Giminiano vengono condannati per tortura e lesioni aggravate in concorso. Le pene vanno dai due anni e tre mesi ai due anni e otto mesi.
Nell’aprile 2021 viene fissata l’udienza preliminare innanzi al Tribunale di Monza a carico di cinque agenti di polizia penitenziaria per i reati di lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata, abuso d’ufficio e omessa denuncia.
Una grave situazione che nel tempo non è né migliorata né progredita. In Europa il disagio carcerario, ad esempio misurabile con il tasso di suicidi, è presente nei Paesi più avanzati: Francia, Austria, Germania, Gran Bretagna. E’ un dato di fatto quindi che il sistema carcerario non funziona, non concede opportunità. Il carcere è l’unica istituzione sociale che la modernità non riesce a migliorare progressivamente, perlomeno se confrontata con le altre grandi istituzioni sociali (scolarizzazione, sanità, servizi, infrastrutture).
Le carceri, così come concepite fino ad oggi, si sviluppano ma non progrediscono.
Negli anni ’70, dopo la riforma del codice fascista degli istituti di pena, Parma e Mario Tommasini entrano nel dibattito ideologico delle istituzioni totali, carceri e manicomi, e lasciano una traccia
precisa nell’evoluzione delle stesse nello statuto italiano.
E’ del dicembre 1984 lo storico convegno ”Liberarsi dalla necessità del carcere”, in cui Jeremy Bentham e il suo Panopticon viene messo in crisi da Mario Tommasini. Un anno dopo viene promulgata la legge Gozzini, che deve la sua formulazione anche e proprio a quel convegno e agli esiti che produsse.
E’ da lì che bisogna ripartire per nuove progettualità, che diano vigore ai principi sostenuti da tante persone che, come noi, condividono l’idea della necessità di riaffermare che la pena, da scontare, deve comprendere la sua funzione “rieducativa”, di opportunità, di riscatto e di reinserimento sociale, confutando l’istituzione totale.
Un percorso iniziato tanti anni fa da Mario Tommasini e di cui la cooperativa Sirio è oggi un esempio positivo e riuscito, dove tante persone che ci hanno lavorato e ci lavorano hanno trovato un’opportunità di inclusione sociale e di inserimento lavorativo.
Si legge nella homepage del sito della cooperativa: “In carcere passavo le giornate a guardare le pareti della mia cella. Oggi, quando esco per andare a lavorare sono orgoglioso. Salgo sul mio camioncino e inizio il giro di raccolta. La gente mi conosce, i commercianti mi salutano. Vedo la mia famiglia. Alla sera rientro in carcere perché devo ancora finire di scontare la mia pena. Ma so che il giorno dopo sarò di nuovo utile a qualcuno (Carlo, operatore Sirio). Lavorare con e per la città li ha resi protagonisti nelle strade, tra la gente, con i commercianti, rafforzando un rapporto di fiducia che nel tempo ha trasformato il lavoro in una professione. Con dignità e orgoglio”.
Fondazione Mario Tommasini