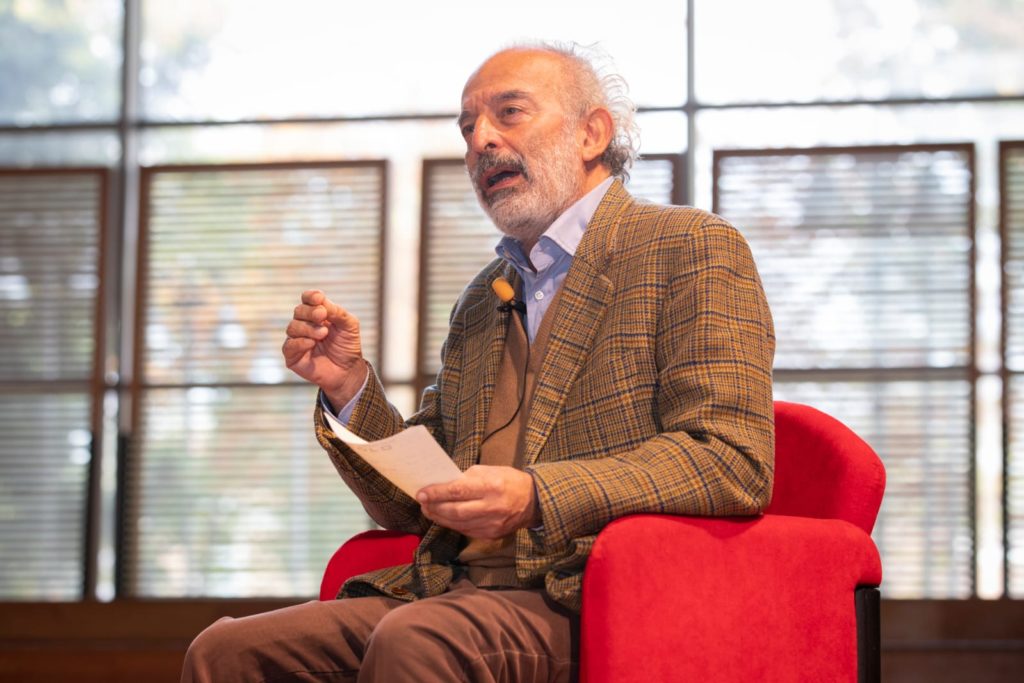Buongiorno Max, grazie per la disponibilità ad essere intervistato su un tema così importante, complesso e credo poco conosciuto: lascio che sia tu a presentarti ai lettori…
Sono Max Ravanetti, vivo e lavoro a Parma. Mi definisco sempre un educatore prestato al sindacato. Credo che tra le due professioni ci sia un segno di continuità, che da il senso della misura di cosa intenda io per vivere. Se poi ci metti che sono appassionato di musica tanto quanto di calcio e che in queste due ultime attività creative/ricreative metto sempre energie e passione, credo che il “gioco” sia fatto su come mi veda io. Magari molti mi vedono in altro modo, ma tant’è.
Max, se dovessi spiegare ad una persona appena conosciuta la giustizia riparativa, cosa gli diresti?
Come definizione tecnica le direi qualsiasi procedimento che permetta alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale. Poi, personalmente le direi che è qualcosa di prezioso. Uno strumento che va colto e che permette di elaborare il passato e da strumenti per il futuro. Credo che sia una opportunità che bisogna darsi senza pregiudizi e senza preconcetti e che ci si debba mettere in ascolto. Le elaborazioni possono essere sia storiche che di analisi sociali e rapporti personali. Questo è ciò che direi perché mi ritengo un messaggero che porta alla luce le persone che hanno vissuto ed attuato questi percorsi che mi hanno coinvolto e fatto sentire parte di un percorso.
Quando e come è nato il tuo interesse per la giustizia riparativa?
E’ una storia difficile da spiegare in poche parole ma ci provo. Parto dal Max bambino di 7 anni e ricordo come fosse ora il sequestro e poi l’omicidio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Ero un bambino come tanti, con le sue paure ed i suoi “interessi”: il calcio (tanto tanto calcio), i giochi in cortile tra i più disparati. Ricordo di come mi divertivo con molto poco. Mio padre era un metalmeccanico e mia madre faceva le pulizie in casa di un pezzo grosso in città: oggi le chiamano colf, allora “donna delle pulizie”. In quegli anni la tv non aveva filtri e già da bambino percepivo come la violenza fosse uno strumento con cui si faceva politica: lo respiravi dalla tv, dai discorsi che “i grandi” facevano a tavola rispetto a ciò che la nostra società stava vivendo.
Crescendo, ho sempre avuto dentro quel pezzo di vita come un lutto non elaborato o come la voglia di capire. Così, negli anni ho iniziato a leggere tutto su quelli che vengono definiti “gli anni di Piombo”: libri, saggi, articoli, guardato documentari ed interviste o spettacoli teatrali. Posseggo un numero di libri e video esorbitante su quegli anni. Poi ho iniziato anche a cercare di capire cosa ne avrei voluto fare di tutte quelle informazioni: un libro? No, non ho velleità e capacità letterarie. Uno spettacolo? No, non saprei ne come e ne mettere in ordine i contenuti.
Insomma, avevi una vera passione su questi temi, ma non avevi ancora idea di come svilupparli?
Non sapevo proprio. Allora iniziai a cercare giornalisti o addirittura testimoni diretti coinvolti in quegli anni. Ho incontrato e partecipato ad appuntamenti di giornalisti come Giovanni Fasanella ma, pensai che no, non mi interessava parlare di quei fatti nel suo modo. Non amo la dietrologia da sempre e non mi piace disquisire su teorie complottiste, che lasciano marginali le questioni umane. Fu così che, nei primi anni ’90, mi imbattei nell’intervista che Sergio Zavoli fece a Franco Bonisoli, ex appartenente alle Brigate Rosse, membro del comitato esecutivo e coinvolto nel caso Moro: fu un’illuminazione. Il modo in cui quel giornalista riuscì a mettere in luce l’aspetto umano di una persona che sa di averla fatta grossa ma non chiede nulla e che si fa carico e responsabile del dolore creato mi lasciò affascinato.
Mi colpì positivamente anche come Franco – oggi lo chiamo così perché è uno dei miei amici più preziosi per me – provava dolore, forte e sincero senza barriere: si mise veramente a nudo ed in un Paese come il nostro credo possa anche essere pericoloso. Tieni presente che Franco ancora non aveva fatto il percorso di giustizia riparativa. Ancora non sapevo dove sarei arrivato ma quella fu una lampadina. Dopo quasi 28 anni, le mie continue ricerche mi fanno scoprire “il gruppo dell’incontro” del quale c’è anche il libro, che ovviamente ho comprato e letto, e grazie al quale ho scoperto di queste persone (ex appartenenti alla lotta armata e figli di vittime), che si son incontrate in un percorso mediato da Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato e Padre Guido Bertagna.
Un percorso decennale, all’inizio protetto e non pubblico. Ne venni in contatto grazie ad una mail che spedii ad Adriana Faranda, la quale mi rispose subito in maniera entusiasta. Da li, la prima edizione dell’iniziativa “Vivere e Non Sopravvivere”
“Vivere e Non Sopravvivere”: un’iniziativa pubblica portata avanti da alcuni anni a Parma con coraggio e crescente risposta di interesse: ci fai una sintesi? Come si evolverà in futuro?
È stata un’iniziativa alla quale ho dedicato molto del mio tempo libero. Ma devo ringraziare prima di tutto la CGIL di Parma, nelle persone di Massimo Bussandri (oggi al Regionale) e Lisa Gattini, attuale Segretaria della Camera del Lavoro di Parma – quest’ultima anche per i contributi preziosi che hanno arricchito l’iniziativa – per il coraggio e la forza con cui hanno sostenuto questo progetto.
Ultima, ma non ultima, Carla Chiappini, giornalista che collabora con “Ristretti Orizzonti”, una redazione di detenuti all’interno degli istituti penitenziari. Oggi Carla, donna di altissima sensibilità, è parte piena di questo progetto e stiamo lavorando insieme per renderlo sempre più fruibile. Non è facile andare oltre alle resistenze e le diffidenze.
Ho organizzato 3 appuntamenti, il primo e l’ultimo sono stati i più ricchi a mio modo di vedere, il secondo quasi un passaggio necessario che mi ha dato spunti di riflessione: ad esempio ho compreso che il “pallino” è meglio averlo sempre sotto controllo e che l’organizzazione deve sempre essere condivisa con poche persone e fidate.
Per questo credo che la terza edizione abbia avuto un grande riscontro ed una crescente risposta.
Sto cercando di portare l’iniziativa a livello nazionale e ci sto lavorando insieme a Carla. Per ora questo lavoro lo “proteggo” ma, appena avrò news, promesso che ti aggiornerò.
Buona parte del tuo lavoro si svolge con le scuole: come ti poni con gli studenti? Quale ritorno hai dall’incontro con loro su questi temi complessi e articolati? Banalmente, come vedi i giovani di oggi?
Mi pongo proprio come messaggero, scusa se ripeto spesso il termine. Mi pongo come una persona che vuol dare un’opportunità. Non mi impongo, cerco di stimolare l’ascolto e l’uso delle parole. I ritorni sono davvero preziosi: in alcuni istituti siamo tornati per quella che viene definita restituzione e dagli studenti, tramite gli incontri ma anche tramite le domande o le riflessioni che mi inviano.
Percepisco la voglia e la “sete” di capire e comprendere non solo il percorso e gli strumenti, ma anche la voglia di ricostruire storicamente la storia di questo Paese.
Come dice Aluisi Tosolini, Preside del Liceo Bertolucci, per cui nutro una stima infinita, “una scuola che non affronta i suoi nervi scoperti, non è una scuola”: io spesso questo pensiero lo applico anche a questo Paese, che ancora oggi fa fatica ad affrontare quella storia ed i percorsi di oggi di chi quegli anni li ha vissuti e in un certo senso “fatti” o “subiti”.
In questo tuo attuale percorso, ti senti ancora educatore? Quanto ti è utile il lavoro ventennale nei servizi educativi nell’affrontare le esperienze collegate alla giustizia ripartiva?
Bella questa domanda. Si. Mi sento pienamente educatore ogni istante e soprattutto nell’approccio a questi percorsi. Aggiungo che, da quando tratto il tema della giustizia riparativa, ho cambiato anche i miei paradigmi rispetto al lavoro: infatti mi sento educatore anche nel lavoro da sindacalista.
Molto bella questa risposta! Max, in questa esperienza, hai conosciuto, anzi, ti sei immerso in un mondo complicato, a volte oscuro e sconosciuto ai più: se dovessi sintetizzare in poche righe, cosa ne hai tratto e in quali contenuti ti sei arricchito?
Sono grato a persone come Agnese Moro, Giorgio Bazzega, Franco Bonisoli, Manlio Milani , Adriana Faranda e Fiammetta Borsellino, ma anche Carla Chiappini ed i compagni della CGIL di Parma, che oggi sono anche amici preziosi. Con ognuno di loro ho un vero rapporto amicale stretto. Con Giorgio Bazzega, oggi uno dei miei migliori amici, siamo spesso insieme a programmare e progettare visto che si è trasferito vicino a Parma. Mi sono arricchito di tante cose, ma su tutte ho imparato ad ascoltare e a non dare mai nulla di scontato. Ho imparato a non avere mai pregiudizi. Ho imparato a disarmarmi per comprendere. Ammetto, non senza ogni tanto scivolare in questa società complessa. Ma questo “mondo complicato”, come giustamente lo hai definito, mi permette anche di cogliere anche i miei errori e di elaborarli e ripararli.
Uscendo un attimo dal tema, mi hai detto di essere uscito dai social network: per quale motivo? Credo possa essere importante che si sappia…
Ecco, mi sono guardato. Avevo perso completamente il controllo quando ero sui social. Non stavo “zitto” e spesso ho fatto passare messaggi contrari a ciò che volevo dire. Non sono uno che ha dimestichezza con la scrittura e non ho velleità letterarie.
Il social, se non ne sai fare un buon uso, può diventare un boomerang dove le persone ti scaricano addosso il loro meccanismo mentale e ciò che in realtà sono loro. Spesso, sono proprio le persone della mia generazione a fare un uso dei social in un certo senso violento. Oppure lo usano come una passerella sulla quale ostentare la propria immagine. Ho conosciuto persone terze, tramite “Vivere e Non Sopravvivere” che sui social ed a livello pubblico davano un’immagine di sé completamente diversa da ciò che poi sono nel proprio privato.
Ecco, io ero parte di quei meccanismi e dinamiche, che oggi guardo con sospetto, anche se sono sempre stato me stesso: non ho alcuna velleità, nessuna voglia di emergere. Solo tanta voglia di condividere insieme.
Il carcere nel 2022: quale realtà è, a Parma innanzitutto? Quali cose possono e devono migliorare? Come si può essere utili, anche da fuori, ad un miglioramento della situazione e delle criticità legate al carcere e ai percorsi di reinserimento sociale, come semplici cittadini?
È un altro tema complesso. Il sistema penitenziario a mio parere sta attraversando una profonda fase di cambiamento. La pena inflitta viene percepita dalla popolazione come una sorta di vendetta e questo è contrario all’art. 27 della Costituzione.
Per citare Agnese Moro o Giorgio Bazzega, credo che la società tutta debba mettersi nell’ottica di riaccogliere le persone “ristrette” (ovvero detenute, ndr) che hanno sbagliato, o che hanno compiuto un grave reato, e non tendere a isolarle semplicemente.
In generale credo che per affrontare alcune criticità, come anche questa nello specifico, servano profonde riflessioni a livello sociale. È chiaro come il carcere sia importante per fermare chi commette un reato, per dargli un “alt”, ma poi è necessario trovare forme che rispettino l’art 27 della Costituzione e che quindi riconoscano l’individuo in quanto tale. Perché vedi Alberto, non c’è alcuna giustificazione che si possa dare a chi commette un reato, ma ho imparato che chiedersi il perché alcuni reati “accadono”, o perché ci sia recidiva da parte di chi esce dal carcere, sia un buon punto di partenza per agire sulle cause e far si che non vi sia sola e semplice repressione.
Faccio sempre un esempio molto semplice e “terra terra”: se sotto casa mia rubano una macchina, magari la mia, spero che l’autore del reato venga preso e ne paghi le conseguenze, facendogli però comprendere la gravità del gesto. Ma se sotto casa e solo sotto casa e nel mio quartiere, rubano tre macchine a settimana, spero si che venga fermata questa pratica, ma insieme mi chiedo il perché accada tutte le settimane e solo sotto casa mia. Ed è da li che si parte per poter agire in linea con la Costituzione.
Alberto Padovani