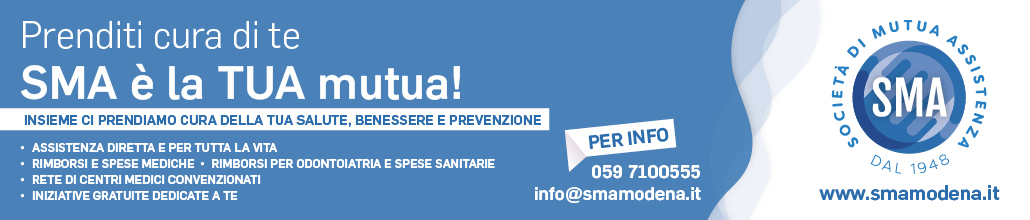Il 14 agosto 1861 il massacro di Pontelandolfo e Casalduni viene perpetrato dal neonato Esercito Italiano.
La decisione di eseguire la rappresaglia fu presa in seguito al precedente massacro di 45 militari dell’esercito unitario (un ufficiale, quaranta bersaglieri e quattro carabinieri), catturati alcuni giorni prima da alcuni “briganti” e contadini del posto. I due piccoli centri vennero quasi rasi al suolo, lasciando circa 3.000 persone senza dimora.
Il numero di vittime è tuttora incerto, ma indicato dalla letteratura revisionista neoborbonica come compreso fra il centinaio e il migliaio[1]. Sulla base della lettura dei registri parrocchiali della chiesa della Santissima Annunziata ove sarebbero annotati dal canonico Pietro Biondi e dal canonico Michelangelo Caterini (firmatario degli atti di morte) i nomi dei morti, le modalità della loro morte e il luogo del seppellimento: 13 persone (undici uomini e due donne) sarebbero morte durante il giorno stesso della strage (dieci direttamente uccisi e due nel rogo delle case) e una tredicesima morì il giorno seguente.
Il numero di 13 morti viene confermato nel 2016 dalla scoperta di una lettera d’epoca datata 3 settembre 1861 pubblicata sulla rivista Frammenti del Centro culturale per lo studio della civiltà contadina nel Sannio con sede in Campolattaro. L’autrice della lettera è la signora Carolina Lombardi, originaria di Pontelandolfo, sposata con don Salvadore Tedeschi, speziale in Compolattaro.
All’indomani della proclamazione del Regno d’Italia, in molte parti dei territori dell’ex Regno delle Due Sicilie scoppiarono moti di rivolta filoborbonici, spesso capeggiati da cittadini o ex militari del disciolto Esercito delle Due Sicilie. Uno di questi moti ebbe luogo il 7 agosto 1861 quando alcuni briganti della brigata Fra Diavolo, comandati da un ex sergente borbonico, il cerretese Cosimo Giordano, approfittando dell’allontanamento di una truppa delle Guardie Nazionali da Pontelandolfo, occupò il paese, uccidendo i pochi ufficiali rimasti, issandovi la bandiera borbonica e proclamandovi un governo provvisorio.
L’11 agosto il luogotenente Cesare Augusto Bracci, incaricato di effettuare una ricognizione, si diresse verso Pontelandolfo alla guida di quaranta soldati e quattro carabinieri. Nei pressi del paese, gli uomini del reparto piemontese furono catturati da un gruppo di briganti e contadini armati che li portarono a Casalduni, dove furono uccisi per ordine del brigante Angelo Pica.
Un sergente del reparto sfuggì alla cattura e successiva uccisione e riuscì a raggiungere Benevento, dove informò i suoi superiori dell’accaduto. Costoro chiesero a loro volta un dettagliato rapporto ai capitani locali della Guardia Nazionale Saverio Mazzaccara e Achille Jacobelli. Ottenuti dettagli sull’accaduto, le autorità di Benevento informarono quindi il generale Enrico Cialdini. Racconta Carlo Melegari, a quel tempo ufficiale dei bersaglieri, che il rapporto inviato a Cialdini conteneva una descrizione raccapricciante dell’uccisione dei bersaglieri. Cialdini, consultandosi con altri generali, ordinò l’incendio di Pontelandolfo e Casalduni con la fucilazione di tutti gli abitanti dei due paesi “meno i figli, le donne e gli infermi”.
Il generale Cialdini, per l’attuazione del piano, incaricò il colonnello Pier Eleonoro Negri e il maggiore Melegari, che comandavano due reparti diretti rispettivamente a Pontelandolfo e a Casalduni. All’alba del 14 agosto i soldati raggiunsero i due paesi. Mentre Casalduni fu trovata quasi disabitata (gran parte degli abitanti riuscì a fuggire dopo aver saputo dell’arrivo delle truppe), a Pontelandolfo i cittadini vennero sorpresi nel sonno. Le chiese furono assaltate, le case furono dapprima saccheggiate per poi essere incendiate con le persone che ancora vi dormivano. In alcuni casi, i bersaglieri attesero che i civili uscissero delle loro abitazioni in fiamme per poter sparare loro non appena fossero stati allo scoperto. Gli uomini furono fucilati mentre le donne (nonostante l’ordine di risparmiarle) furono sottoposte a sevizie o addirittura vennero violentate.
Alcuni particolari del massacro si leggono nella relazione parlamentare che il deputato Giuseppe Ferrari scrisse a seguito del suo sopralluogo a Pontelandolfo all’indomani del terribile evento. Nella relazione si citano due fratelli Rinaldi, uno avvocato e un altro negoziante, entrambi liberali convinti. I fratelli, usciti fuori di casa per vedere cosa stesse accadendo, vennero freddati all’istante e uno dei due, ancora in agonia dopo i colpi di fucile, fu finito a colpi di baionetta. Un altro episodio citato è quello di una ragazza, tale Concetta Biondi, che rifiutandosi di essere violentata da alcuni soldati, fu fucilata
Al termine del massacro, il colonnello Negri telegrafò a Cialdini: “Ieri mattina all’alba giustizia fu fatta contro Pontelandolfo e Casalduni. Essi bruciano ancora”.
A causa dell’incendio degli archivi comunali e della mancanza di un censimento non si conosce la cifra esatta delle vittime del massacro. Alcune stime parlano di circa 100 civili uccisi, altre di 400, altre di circa 900 ed altre ancora di almeno un migliaio.
Una forte revisione al ribasso del numero degli uccisi, ridotti a 13 morti, viene sostenuta dal ricercatore Davide Fernando Panella sulla base della lettura dei registri parrocchiali della chiesa della Santissima Annunziata ove sarebbero annotati dal canonico Pietro Biondi e dal canonico Michelangelo Caterini (firmatario degli atti di morte) i nomi dei morti, le modalità della loro morte e il luogo del seppellimento: 12 persone (undici uomini e due donne) sarebbero morte durante il giorno stesso della strage (dieci direttamente uccisi e due nel rogo delle case) e una tredicesima morì il giorno seguente.
Il 14 agosto del 1973, il gruppo musicale milanese degli Stormy Six, tenne in Pontelandolfo un concerto nel corso del quale, con una canzone di protesta, si denunciò “la grande macchia della Storia italiana”. In seguito all’evento, i familiari delle vittime lanciarono la prima petizione per chiedere la verità sul massacro.
Un secolo e mezzo dopo i fatti, il 14 agosto 2011, Giuliano Amato, presidente del comitato per le celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità d’Italia, ha commemorato quella strage, porgendo a tutti gli abitanti di quella che è stata definita «città martire», le scuse dell’Italia.