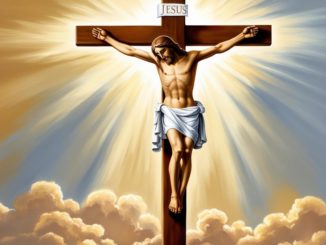23/04/2015
ACCADDE OGGI: Il 22 Aprile 1915 forze tedesche impegnate sul fronte occidentale impiegarono per la prima volta il gas durante un attacco condotto contro due divisioni alleate nell’area di Ypres. Gli effetti furono devastanti al punto tale che perfino i Tedeschi ne furono scioccati.
Fumi tossici erano stati già impiegati in guerra già a partire dai tempi antichi. In epoca a noi più vicina, precisamente nel 1912, in Francia le forze dell’ordine utilizzarono gas lacrimogeno durante operazioni di polizia. Allo scoppio del primo conflitto mondiale la Germania iniziò a sviluppare ricerche nel campo dell’impiego di armi chimiche e, nel corso di un attacco a Neuve Chapelle nell’Ottobre del ’14, i Tedeschi lanciarono piccoli contenitori di gas lacrimogeno, che però non riuscirono a raggiungere le postazioni difese dagli alleati. Nel Gennaio dell’anno successivo a Bolimov impiegarono composti più letali a base di bromuro contro truppe russe. A causa delle basse temperature la miscela gassosa gelò, perdendo la sua forza distruttiva, ma pur causando circa un migliaio di vittime. Il 22 Aprile durante la seconda battaglia di Ypres, dopo il normale bombardamento di artiglieria, gli alleati attendevano nelle trincee l’avanzata tedesca verso le proprie posizioni. Nelle loro fila si diffuse invece un senso di sbigottimento che si trasformò presto in panico quando alle ore 5 del pomeriggio vi fu un nuovo bombardamento e questa volta videro che la terra di nessuno fra i due schieramenti e le loro trincee venivano inondate da gas al cloro. L’artiglieria tedesca ne lanciò precisamente 160 tonnellate. Una nube verde-giallastra, larga 10 chilometri e della profondità di un chilometro, investi le linee alleate, oscurò il sole e rapidamente, sospinta dal vento, si riversò sulle posizioni tenute dalla 87° divisione francese e dalla 45° divisione algerina, che fu letteralmente decimata. Truppe canadesi, poste alla destra delle linee francesi, videro tutt’attorno al fiume Yser e ai canali circostanti il terreno avvolto dalla nube del micidiale composto che avanzava ricoprendo ogni cosa. Coloro che poterono evacuare le trincee in tutta fretta fuggirono in direzione di Ypres. Uno soldato canadese ricordò come “Una compatta marea… si mosse verso di noi in direzione di Ypres, lasciandoci poco spazio. . . e, naturalmente, c’erano i feriti – centinaia di loro – e il corpo principale delle truppe coloniali francesi in ritirata, alcuni dei quali erano stati gassati, con facce gialle e che respiravano a fatica”. Un altro, osservando le postazioni evacuate dopo che la nube si era dispersa non poteva credere ai suoi occhi quando vide “la trincea… ricoperta dai cadaveri di coloro che erano stati gassati. Dovevano essere migliaia”. Si aprì una breccia di circa un chilometro e mezzo all’interno della quale le truppe tedesche avanzarono con cautela, oltre la vegetazione e gli animali morti, e le trincee colme di cadaveri.
Ai Canadesi, che di lì a poco sarebbero stati bersagliati dal gas e ancora sprovvisti di ogni tipo di protezione, fu ordinato di strappare pezzi di stoffa dalle loro uniformi, urinarvi sopra e tenerli premuti sul volto. I vapori sprigionati dall’urina servivano a neutralizzare in parte gli effetti del cloro, cristallizzandolo, e coloro che seguirono le istruzioni riuscirono a resistere. Con rinnovata intensità i Tedeschi sferrarono un nuovo attacco ancora più violento il giorno successivo, e di nuovo il 24. I canadesi retrocedettero, ma il nemico non riuscì a sfondare il fronte che, nonostante la varco apertosi due giorni prima, tenne. La seconda battaglia di Ypres si concluse il 25 Maggio con vantaggi territoriali modesti per i Tedeschi e costò ai Canadesi 5.592 tra morti, feriti e dispersi, molti dei quali furono asfissiati dal gas.
Subito dopo l’attacco ad Ypres, Francia e Gran Bretagna iniziarono a sviluppare proprie armi chimiche e maschere antigas. Alcuni strateghi militari difesero l’uso dei gas tossici sostenendo che riducevano la capacità di reazione offensiva del nemico, e quindi, accorciando la durata dei combattimenti, contribuivano alla lunga a salvare vite umane. In realtà, le difese contro il gas tossico di solito tennero il passo con gli sviluppi della tecnica militare, ed entrambe le parti progressivamente impiegarono sofisticate maschere antigas e indumenti protettivi che finirono sostanzialmente per annullare l’importanza strategica delle armi chimiche.
Entrati in guerra nel 1917, anche gli Stati Uniti svilupparono un programma basato sull’impiego di armi chimiche. Complessivamente più di 100.000 tonnellate di agenti chimici furono adoperati nella prima guerra mondiale, causando la morte di 30.000 uomini e il ferimento di altri 500.000.
Dopo la fine del conflitto Gran Bretagna, Francia e Spagna utilizzarono armi chimiche in varie scontri coloniali. Nel 1925 il Protocollo di Ginevra vietò l’uso di armi chimiche in guerra, senza tuttavia dichiarare fuorilegge il loro sviluppo o stoccaggio. La maggior parte delle grandi potenze preparò quindi massicce riserve di armi chimiche. Nel 1930 l’Italia fu la prima nazione ad impiegare armi chimiche contro la popolazione civile durante la guerra per la conquista dell’Etiopia e il Giappone si comportò analogamente nel conflitto contro la Cina. Nella Seconda Guerra Mondiale le armi chimiche non vennero impiegate, in primis poiché tutti i principali belligeranti possedevano sia le armi che gli strumenti di difesa, come le maschere antigas, indumenti protettivi, e rilevatori, che rendevano inefficace l’uso del gas. In compenso la Germania utilizzò gas tossici per uccidere milioni di deportati nei campi di sterminio.
Dal 1945 le armi chimiche sono state utilizzate solo in pochi conflitti: nello Yemen nel 1966-67 e durante la guerra fra Iran e Iraq del 1980-88, e sempre contro forze sprovviste di maschere antigas o altri strumenti di difesa. Nel 1990 gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica siglarono un accordo per ridurre i rispettivi arsenali di armi chimiche dell’80% nel tentativo di scoraggiare le nazioni più piccole allo stoccaggio. Nel 1993 venne firmato un trattato internazionale che vietava la produzione, lo stoccaggio a partire dal 2007, e l’impiego di armi chimiche. Entrato in vigore nel 1997, è stato ratificato da 128 nazioni.
Alessandro Guardamagna