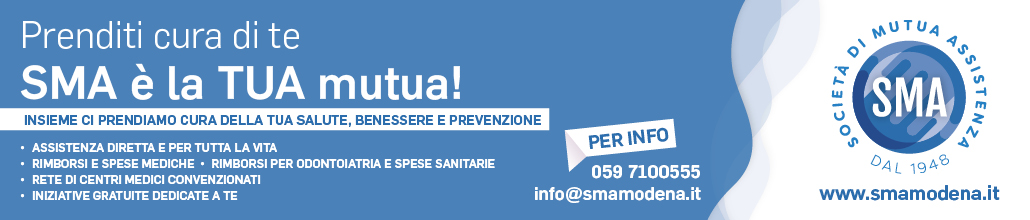26/06/2015
E’ positivo e soddisfatto il giudizio che il Senatore Pd Giorgio Pagliari, autore della dichiarazione di voto a nome del gruppo nel corso del dibattito, esprime in merito alla approvazione della fiducia al governo sul decreto La buona scuola,. “E’ stato il passaggio più duro della mia vita parlamentare – afferma il Senatore Giorgio Pagliari – Lo scontro c’è stato e temo rimarrà ancora per un po’ di tempo, ma superamento del precariato, assunzioni, ridisegno dei ruoli degli organi della scuola, inversione di tendenza sul piano degli investimenti nella e per la scuola, gradualità della riforma e previsione della verifica sono elementi qualificanti della scelta operata.
Al netto delle posizioni pregiudiziali o di contrarietà a prescindere che hanno avvilito il dibattito parlamentare e non solo oggi, possiamo dire che non si è chiuso ma si è aperto un percorso per una scuola più al passo con i tempi e maggiormente responsabilizzante. La sfida è di tutti, ed è in funzione degli alunni”.
___
Pagliari ha postato su Facebook il suo intervento per la dichiarazione di voto del Gruppo PD al Senato sulle pregiudiziali al DDL #SCUOLA:
“Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Partito Democratico voterà contro queste pregiudiziali, e lo farà per ragioni ben precise, legate proprio agli articoli che sono stati citati nel corso di questa discussione.
Si è posto il problema dell’organizzazione della scuola attraverso i poteri attribuiti al dirigente; si è posto il problema, nella discussione, della inadeguatezza di un modello verticistico della scuola. Credo che valutazioni politiche di questo tipo si possano fare, ma quando si parla di Costituzione e di dettati normativi siamo ben lontani da tutto questo.
Abbiamo una organizzazione che, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione (che prevede che per legge si attribuiscano le competenze dei pubblici uffici) stabilisce all’interno della scuola un ordine di competenze e una ripartizione di compiti che fa sì che questa scuola dell’autonomia abbia un riferimento, un responsabile preciso, quale è il preside, in una logica che peraltro tiene conto di tutte le componenti della scuola: del collegio di istituto, del collegio dei docenti, delle rappresentanze dei genitori e degli insegnanti. Tutto questo è nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, nonché dell’articolo 33 della stessa Carta.
Si dice che viene violata la libertà dell’insegnamento. Sotto quale profilo viene violata tale libertà? E prima ancora, cosa significa libertà dell’insegnamento? Significa la possibilità di impostare il proprio insegnamento, le lezioni, la diffusione del proprio sapere secondo il proprio discernimento, ma non significa che ci si sottragga al principio fondamentale della responsabilità sancito dall’articolo 28 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD). Non significa che la libertà non comporti che ci sia una valutazione dell’operato, perché questo avviene in tutte le democrazie, in tutte le organizzazioni pubbliche e private. Non significa che si toglie la libertà all’insegnante di esprimersi come meglio credo.
L’insegnante, che è consapevole delle proprie attribuzioni, della propria competenza e della propria professionalità, non può avere timore di una valutazione. La valutazione è ciò che meglio dà il metro all’insegnante rispetto al suo modo di esercitare il ruolo, rispetto al suo modo di essere nella scuola. Questa valutazione, come avviene all’università – naturalmente con gli elementi di diversità che vanno sicuramente impostati – non può prescindere dal contesto in cui l’insegnante opera. La valutazione non valuta il tasso di scientificità dell’insegnante. Certo, ci vuole una preparazione approfondita; ci vuole certamente una competenza consolidata; ma l’insegnante intanto si qualifica tale non se è un premio Nobel, ma se è insegnante, se nel contesto sa rapportarsi con gli studenti, sa formarli ed educarli (Applausi dal Gruppo PD); sa muoversi nei confronti degli insegnanti, dei genitori, dei ragazzi e di tutti gli operatori della scuola, perché l’insegnante non è un atomo della scuola ma un operatore della scuola e, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, nella specificità della sua funzione è uguale a tutti gli altri. Nella funzione di una scuola moderna, di una scuola che deve affermarsi sul piano del merito e della competenza, questa è una strada seria, consapevole, assolutamente conforme alla Costituzione, al principio di uguaglianza, prima ancora che alla libertà di insegnamento.
Queste sono le regole fondamentali di una democrazia, di un rapporto di lavoro nel pubblico impiego (lo dice l’articolo 97). Di questo credo non si debba avere paura e, sotto questo profilo, l’affermazione che l’insegnante diventa servo credo sia offensiva per gli stessi insegnanti. (Applausi dal Gruppo PD). Credo che, se si ha rispetto dell’insegnante, non lo si definisce servo. Se si pensa che un insegnante sia succube di un preside o della valutazione che viene data, vuol dire che si pensa che l’insegnante non abbia la consapevolezza del proprio ruolo e che non abbia la dignità della propria professione (Applausi dal Gruppo PD)e il rispetto della propria persona. Certo, la vita lavorativa in tutti i contesti è una vita difficile e complicata, in cui ci possono anche essere degli scontri, ma dire che porre una regola che stabilisce un principio di valutazione, riporta a questo principio di valutazione l’operato dell’insegnante e pone l’insegnante a confronto con la valutazione, significa violare la libertà di insegnamento, credo sia davvero eccessivo. Con ciò si pone un altro problema, ovvero se vogliamo provare a riformare la scuola o vogliamo mantenere lo status quo e se, con il contributo di tutti, vogliamo elevare il livello della scuola – di cui non sto a contestare il valore – per renderlo più adeguato al contesto europeo, ad un concetto dinamico di democrazia e di rapporto tra lo stesso docente e i genitori, che nella specificità dei ruoli non viene meno al rilievo dell’articolo 3 della Costituzione, e a un contesto nel quale tutti devono essere consapevoli che ci sono diritti e doveri per tutti e che rispetto a questi diritti e a questi doveri si deve rispondere.
A proposito del tema dell’articolo 34 della Costituzione, si è posto qui il problema dei bonus. Ebbene, credo che su questo tema dovremmo uscire dal contesto delle pregiudiziali, dei guelfi e dei ghibellini, e ricordarci che il bonus fiscale non è un contributo alle scuole, ma rientra nel diritto allo studio, è un contributo allo studente, che andando in una scuola di questo tipo, non è a carico del bilancio pubblico e che si tratta di una detrazione dell’onere che grava sul genitore, parziale e limitata, che non toglie la parità di contributo tra quello che uno studente paga alla scuola pubblica e quello che paga alla scuola privata. Ciò significa semplicemente lasciare una libertà di scelta, che spesso è frutto del diritto al lavoro dei genitori, prima ancora che del diritto all’istruzione. Quando parliamo di questo tema, non parliamo solo delle scuole di élite, ma di quelle a cui spesso si rivolgono i genitori, che avendo situazioni lavorative molto complicate hanno bisogno di particolari regimi di assistenza dei propri figli.
Per ciò che riguarda il tema relativo all’articolo 3 della Costituzione, credo che tutti sappiano che la Corte costituzionale ha detto che tale articolo viene violato quando situazioni uguali vengono trattate in modo diverso, ma non quando, in presenza di elementi oggettivi di diversificazione, c’è una disciplina diversificata, che non è contraria alla logica e non è palesemente irrazionale. Non ho sentito nel dibattito sui presupposti di costituzionalità del disegno di legge in esame nessuna considerazione che ponesse in evidenza una discriminazione non giustificata o che imputasse a queste disposizioni una irrazionalità manifesta. Certo, quando scendiamo sul piano delle scelte politiche, che vengono tradotte nelle norme giuridiche, siamo in un campo nel quale la valutazione politica è sempre discutibile, ma sul piano del sindacato di costituzionalità credo che si debba avere un riferimento serio nella Costituzione, che non può essere utilizzata come uno strumento di propaganda, ma come un riferimento dell’azione e dell’indirizzo politico che tutti dovremmo rispettare, se davvero la vogliamo applicare. Concludo con un riferimento al tema della chiamata diretta, che secondo alcuni elude il principio del concorso.
Credo che, se il contesto cui facciamo riferimento è uguale per tutti, questa sia un’affermazione del tutto gratuita ed inaccettabile. Quando la chiamata viene fatta tra coloro che hanno superato il concorso e quindi sono nella condizione di poter esercitare la funzione di docenti, non c’è nessuna elusione del principio del concorso e la chiamata non esclude, per nessuno degli insegnanti, la certezza del posto e della propria funzione.
Credo che questo sia il quadro di riferimento e per tali ragioni il Gruppo del Partito Democratico voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità.”