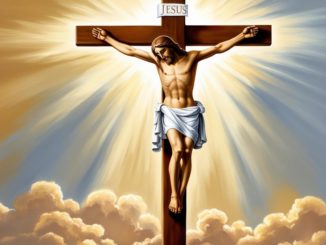Il “dopo i noi”. In molti si sono dedicati a questa nuova legge, approvata da poco in via definitiva alla Camera dei Deputati e non senza contrarietà di parte dell’opposizione. Il “dopo di noi” ha rappresentato da sempre, dai lontani anni ’80, un tema centrale nella vita delle persone disabili e delle loro famiglie.
I commenti e le valutazioni fatte da diverse testate nazionali, mettendo in evidenza punti di vista diversi, sono le più diversificate:alcuni la esaltano segnalando prevalentemente gli elementi positivi e in particolare l’istituzione del fondo, altri la criticano, perché sembra non andare compiutamente nella direzione utile alla vita delle persone disabili, al loro benessere. Per altri ancora si tratta prevalentemente un’operazione economica e finanziaria a favore di interessi già presenti sul territorio nazionale.
E’ da rilevare con soddisfazione l’enfasi data in modo puntuale ai riferimenti costituzionale e alla Convenzione dei diritti dell’ONU.
Nonostante ciò, possiamo ugualmente chiederci se fosse stata così necessaria una legge sul tema del “dopo di noi” in modo specifico: le opinioni affermative prevalgono, ma qualche dubbio rimane perché già abbiamo altre leggi non applicate del tutto e in particolare la 328 del 2000.
Di fatto si inserisce in una giungla di norme non integrate tra loro che sul piano pratico portano solo frammentazione nelle politiche sociali per la disabilità. E questo è un elemento non trascurabile se si tiene conto delle difficoltà di integrazione tra sociale e sanitario e il rispetto dei diritti ai servizi essenziali di assistenza. Possiamo, quindi a ragion veduta, ritenere legittimo e pensare che di questa legge potevamo anche farne a meno; forse bastava aggiornare e, soprattutto, controllare il rispetto di quelle esistenti, in particolare modo la 104 del 1992 e tenere conto della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Così per gli aspetti economici si poteva incrementare il fondo per la non autosufficienza.
Ma la legge c’è e dovrà, perciò, essere applicata. Due aspetti importanti, per molti, sono rappresentati dall’istituzione di un fondo ad hoc e la defiscalizzazione di molte operazioni a carattere economico rispetto ad alcuni strumenti adottabili come il trust1, assicurazioni sulla vita e altro ancora. Il fondo e la defiscalizzazione hanno già svegliato, ovviamente, alcuni appetiti da parte di grandi organizzazioni ONLUS.
Alcune riflessioni meritano però di essere fatto almeno su quattro temi: il durante noi, i destinatari, le azioni possibili– vale a dire la domiciliarità e la deistituzionalizzazione– gli strumenti operativi.
Purtroppo il tema del “durante noi”, vale dire il presente, l’adesso delle persone disabili non è preso in considerazione esplicitamente così come è ancora ignorata la costruzione del percorso personale alla vita adulta, che coincide con le esperienze di vita indipendente fisica e psicologica e, quindi, con la realizzazione di una necessaria emancipazione dalla e della famiglia.
Non si tratta di negare l’impegno familiare, che c’è e ha dovuto, da sempre, riempire i vuoti lasciati dalle politiche sociali ed educative, (non sempre adeguate alle necessità assistenziali e abilitative dei figli e delle figlie), ma di riconoscere ai cittadini disabili il diritto ad una adultità in proprio, cioè autonoma se pur, ovviamente, con i supporti necessari che, in primis vanno programmati e via via continuamente aggiornati dal welfare pubblico. La legge,di fatto,riconosce solo implicitamente il “durante noi” quando nel testo scrive “… nonché in vista (chiave preventiva) del venir meno del sostegno famigliare …”dando per scontato che in questo “durante” sia per così dire naturale che la famiglia (peraltro numericamente sempre più ridotta e più attenta a diritti di cittadinanza di tutti i suoi membri) possa/debba continuare, almeno fino alla morte dei genitori, a mantenere una situazione di convivenza di questi ultimi con i loro figli disabili. Con ciò sottovalutando l’estrema urgenza, che invece esiste, di sviluppare politiche concrete e diffuse orientate allo sviluppo dei processi di autonomia per tutti i disabili tesi ad aggiornare, flessibilizzare, meglio qualificare e mettere in campo nuove risorse, opportunità, servizi (art. 4, commi a e d).
Pertanto riteniamo di fondamentale importanza che le politiche di welfare assumano fin da oggi il “durante noi”, per dare continuità e sostanza “concreta” a tutti i processi di inclusione sociale avviati fin dai primi anni di vita con la frequenza scolastica nella scuola di tutti . Senza questa continuità si rischia di vanificare tutto il lavoro fatto in età evolutiva orientato a sviluppare la maggior autonomia possibile nella la vita adulta.
Il secondo tema portante della legge riguarda i destinatari. Leggiamo con piacere che la medesima è rivolta a chi si trova in situazione di disabilità “grave”. Per la definizione di gravità, la legge fa riferimento all’art. 4 della 104/92. Anche se si tratta di un linguaggio superato (infatti poteva fare riferimento all’ICF – Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute – 2001 – dell’OMS), di fatto, fino ad ora la cultura dominante vede/pensa ancora le persone definite gravi o in istituti di una certa consistenza numerica o in centri socio-riabilitativi. Questa legge può quindi diventare un’occasione unica e definitiva per mettere mano ai grandi e meno grandi istituti ancora presenti sul nostro territorio nazionale, compresa l’Emilia Romagna. Per molti aspetti, infatti, siamo rimasti all’era di pre-chiusura dei manicomi, ma è possibile fare leva su un passaggio della legge quando dice che la “deistituzionalizzazione è la finalità primaria” per chiudere definitivamente questa stagione. Dobbiamo dire basta alle ghettizzazioni vecchie e nuove, perché sono, di fatto, segregazioni dentro dei luoghi che limitano la vita di tutti. Non sarà facile concretamente, e non solo a parole, “dismettere davvero ” quei grandi contenitori di disabili di cui abbiamo conoscenza in quanto sicuramente si frapporranno interessi economici di un certo rilievo. L’impegno di tutti deve essere quello di chiudere le istituzioni “totali” e non continuare a costruire Centri socio riabilitativi residenziali ampi e sempre più numerosi.
Certamente il termine disabilita “grave” rimane nella legge alquanto generico, ma la filosofia più generale che la ispira può aiutare a una interpretazione ampia del termine per ricomprendere tutte le diverse disabilità e in questo senso speriamo che le linee guida di prossima emanazione vadano in tale direzione favorendo al fine di costruire luoghi di vita vera, piccole comunità a carattere domestico e famigliare capaci di rispondere ai reali bisogni e desideri delle persone che decidono di abitarle.
Purtroppo,se la legge viene intesa invece in senso restrittivo , possono usufruire della medesima solo le persone prive della famiglia o con i famigliari non più in grado di occuparsi di loro oppure per persone non affette da patologie senili “determinate dal naturale invecchiamento” (art. 1, comma 2). Tale impostazione limita di fatto la dimensione dell’opportunità e della esigibilità del diritto ad una vita propria anche mediante una scelta fatta in età adulta. Ciò sembra essere stato determinato dalla esiguità delle risorse economiche disponibili.
Il tema della domiciliarità: tema importante, decisivo per uscire dalla logica dell’istituzione. Non si tratta di una novità per la nostra realtà provinciale; tale tema è presente nel dibattito cittadino fin dagli anni ’80 sulla base delle intuizioni e della capacità di pensare il benessere degli anziani da parte di Mario Tommasini. Ma, in verità, con questa legge la domiciliarità per le persone disabili assume sicuramente un valore più pregnante e, indirettamente fa proprie le esperienze portate avanti in questa direzione già da qualche anno in alcune Regioni d’Italia e anche nella nostra Provincia.
La Domiciliarità, quindi,”per quanto dopo di noi”, è la finalità primaria della legge; infatti afferma “… potenziare programmi di interventi volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni … “ e altre soluzioni sono possibili soltanto in “… via residuale … in soluzioni abitative extrafamigliare … “ (art. 4, lettere a e b). Questo passaggio è molto chiaro.
La Domiciliarità, peraltro, è un diritto (Convenzione dell’ONU del 2006 e ratificata dall’Italia nel 2009) per tutte le persone che scelgono di poter vivere a casa propria o in una casa vissuta come propria e in convivenza con altre persone che scelgono di condividere parte della propria vita. La Domiciliarità è dunque,oggi, una speranza più concreta. Rappresenta un impegno di tutti per costruire modelli esperienziali generalizzati e personalizzati. Negli istituti, infatti,valgono le regole imposte da altri, vale la burocrazia (per chi ha esperienza di case di riposo per anziani), a casa propria vale il benessere personale e comunitario. Per poter realizzare la domiciliarità nel modo migliore occorrerà dare maggiore vita ai servizi socio-sanitari e specialistici territoriali.
La domiciliarità interroga più che mai, oggi, le politiche pubbliche, chiede di modificare il sistema dei Servizi Sociali e Sanitari.
Deve diventare una buona occasione di innovazione.
Infine, il tema degli strumenti utilizzabili non è di facile comprensione, perché complesso e perché richiama diversi altri temi importanti di natura giuridica, finanziaria, economica (il fondo dedicato, le donazioni, i patrimoni personali) e fiscale (art. 5 e 6).
Si tratta di comprendere alcune cose dal punto di vista pragmatico e cioè: come potrà svilupparsi la gestione delle risorse, quali i soggetti abilitati (ONLUS) alla gestione, come conseguire la tutela della persona e dei relativi diritti e infine,da non sottovalutare,gli strumenti del controllo che come noto, sono il grosso tallone di achille del nostro sistema dei servizi.
Nella legge sono già presenti alcuni elementi di gestione, tutela e controllo, ma non sufficienti. Sarà necessario coinvolgere più competenze tecniche. Una parte dell’opposizione ha votato contro proprio a causa della non chiarezza di questi temi e delle modalità di gestione.
Ora dobbiamo attendere i decreti attuativi, che saranno emessi entro sei mesi e le competenze attribuite alle Regioni che dovranno decidere i criteri di gestione del fondo dedicato. Su questo aspetto c’è già chi si sta attrezzando, perché attirati dagli aspetti finanziari ed economici messi a disposizione nel fondo annuale. Presto saremo impegnati e in particolare le famiglie insieme all’ente pubblico, al terzo settore, associazioni di rappresentanza “… nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze …” (art. 4, comma 2).
E’ auspicabile che i Comuni istituiscano un gruppo di lavoro interdisciplinare su questa legge per iniziare a studiare possibili percorsi attuativi a carattere contrattuale, finanziario ed economico e soprattutto sviluppare, insieme ai diversi Soggetti della rete locale, nuovi e più avanzati progetti di domiciliarità secondo percorsi e confronti che assicurino più concretamente un protagonismo reale anche alle famiglie.
Augusto Malerba
psicologo e pedagogista esperto in politiche sociali e progettazione per la disabilità
1 Il trust è un istituto giuridico di contrattazione di origine anglosassone e sottoscritto dall’Italia nella Convenzione dell’Aja nel 1985 diventando esecutivo nel 1992. Per saperne di più si può reperire una piccola pubblicazione 2011, dal del titolo “Fondazione per la Domiciliarità dei Disabili”. a cura della Fondazione Trustee per la Domiciliarità dei disabili. Il contratto di trust è un atto fiduciario tra tre soggetti (persone): un disponente, un beneficiario e un trustee. Il controllo è affidato ai guardiani del trust (due), che verificano la realizzazione puntuale delle finalità per cui è stato istituito il trust.