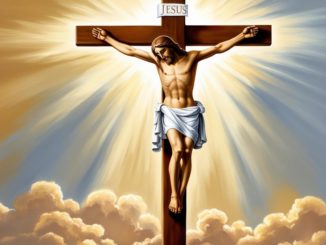Il 25 aprile 1974 in Portogallo l’MFA (Movimento das Forças Armadas) composto da ufficiali e truppe dei diversi corpi delle forze armate, occupa militarmente Lisbona e altre città portoghesi dando vita al colpo di Stato incruento noto come Rivoluzione dei garofani, che mette fine al regime dittatoriale di Marcelo Caetano.
La Rivoluzione dei garofani (in portoghese Revolução dos Cravos) fu il colpo di Stato incruento attuato nel 1974 da militari dell’ala progressista delle forze armate del Portogallo che pose fine al lungo regime autoritario fondato da António Salazar e che portò al ripristino della democrazia nel paese dopo due anni di transizione tormentati da aspre lotte politiche.
La dittatura portoghese traeva origine dal golpe del 28 maggio 1926, che aveva decretato la fine di un breve e turbolento periodo democratico. Nel 1933, con l’approvazione di una nuova Costituzione basata sul corporativismo e sugli ideali fascisti, António de Oliveira Salazar aveva instaurato apertamente il regime dell’Estado Novo. Partito unico era rimasto l’União Nacional (Unione nazionale), di ispirazione nazionalista, corporativa, anti-socialista e fascista.
Durante la Seconda guerra mondiale il Portogallo restò neutrale, e questo gli consentì una relativa crescita economica negli anni quaranta. Nel 1949 cessò l’isolamento politico del regime, che diventò membro fondatore della NATO, tollerato dagli altri stati membri per via delle posizioni fortemente anticomuniste del suo governo.
La libertà politica era fortemente limitata, le elezioni caratterizzate da brogli e altre irregolarità e il regime manteneva uno stretto controllo sulle attività dei cittadini attraverso la polizia politica PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado), successivamente divenuta DGS (Direcção-Geral de Segurança), che perseguitava gli oppositori, spesso arbitrariamente arrestati, torturati e uccisi.
La resistenza del Portogallo alla decolonizzazione provocò l’insorgere di un lungo e improduttivo conflitto tra le forze coloniali portoghesi e i movimenti indipendentisti in Angola, Mozambico, Guinea-Bissau; la situazione internazionale era sfavorevole al regime, in quanto entrambe le superpotenze della Guerra fredda, Stati Uniti e Unione Sovietica, finanziavano i movimenti di liberazione nazionale per cercare di attrarre i paesi di nuova indipendenza nelle rispettive sfere di influenza. Durante la guerra, le Nazioni Unite approvarono sanzioni riguardanti il commercio di armi nei confronti del Portogallo e gli Stati Uniti impedirono l’uso di mezzi NATO per la repressione coloniale, anche se furono costretti a ritirare il loro appoggio ai movimenti di liberazione di fronte alla minaccia portoghese di abbandonare l’organizzazione.
La rapida crescita economica si interruppe alla fine degli anni sessanta, a causa dell’isolamento politico ed economico e della lunga e improduttiva guerra coloniale.
La morte di Salazar nel 1970 non comportò sostanziali evoluzioni del governo, guidato dal successore Marcelo Caetano. All’inizio degli anni settanta il Portogallo era politicamente ed economicamente fiaccato dallo stato di guerra che, proseguendo ormai da quasi due decenni e senza una soluzione politica in vista, risultava particolarmente oneroso in termini di risorse. La situazione portò a un malcontento generale, in particolare nelle classi sociali meno agiate e all’interno delle Forze armate.
All’inizio degli anni settanta alcuni ufficiali subalterni, la maggior parte con il grado di capitano, con idee politiche di sinistra e contrari alla politica governativa, particolarmente riguardo alla guerra coloniale, si associarono, inizialmente nel Movimento dei Capitani (Movimento dos Capitães), successivamente nel Movimento delle Forze Armate (MFA, Movimento das Forças Armadas), organizzato nel 1973 con lo scopo di abbattere l’Estado Novo e avviare il paese sulla strada della democratizzazione, della decolonizzazione e dello sviluppo economico, con gli obiettivi immediati della fine della guerra, della convocazione di elezioni libere e dell’abolizione della polizia politica. Una parte degli ufficiali del Movimento era, invece, legata al generale Kaùlza de Arriaga, ex comandante delle Forze Armate portoghesi in Mozambico, le cui posizioni politiche si ponevano alla destra dello stesso Presidente del Consiglio Caetano, inviso ai duri del regime.
Kaùlza de Arriaga tentò una sollevazione militare contro Caetano nel dicembre 1973 e successivamente strinse un’alleanza sempre più stretta con il Presidente della Repubblica, l’Ammiraglio Américo Thomaz che isolò sempre di più il Presidente Caetano. Nella stessa giornata del 25 aprile 1974, Kaùlza de Arriaga tentò invano di opporsi al colpo di Stato, attraverso un’iniziativa militare di segno opposto. Al Movimento delle Forze Armate rimase sostanzialmente estranea, almeno sino alla mattinata del 25 aprile, la Marina militare, con l’eccezione di alcuni ufficiali isolati ed anzi una fregata, la “Almirante Gago Coutinho”, impegnata nelle manovre NATO, tenne per ore sotto tiro le forze ribelli che assediavano il quartiere dei ministeri.
Il 16 marzo 1974 ci fu un prematuro tentativo di insurrezione, quando il 5º Reggimento di Fanteria marciò su Lisbona, che si concluse con il fallimento del golpe e l’arresto di circa 200 militari. Il 24 marzo una riunione clandestina della commissione coordinatrice dell’MFA deliberò che un nuovo tentativo di colpo di Stato avrebbe dovuto avere luogo tra il 22 e il 29 aprile. Otelo Saraiva de Carvalho fu incaricato di gestire il piano generale delle Operazioni; il programma definitivo del Movimento fu approvato il 21 aprile.
Il 23 aprile Saraiva de Carvalho comunicò che il piano sarebbe stato attuato il 25 aprile e che il posto di comando dell’MFA sarebbe stato installato presso la caserma del 1º Reggimento Genieri a Pontinha.