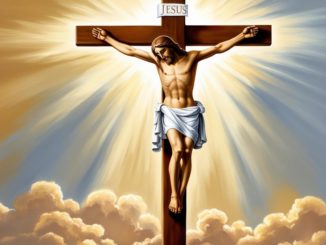Il 15 settembre 1904 nasce a Raconigi Umberto II.
Umberto II di Savoia è stato luogotenente generale del Regno d’Italia dal 1944 al 1946 e ultimo re d’Italia, dal 9 maggio 1946 al 18 giugno dello stesso anno, data in cui fu ufficializzato il risultato del referendum istituzionale del 2 giugno, sebbene già dal 13 giugno il consiglio dei ministri avesse trasferito ad Alcide De Gasperi, con un gesto che Umberto II definì rivoluzionario, le funzioni accessorie di Capo provvisorio dello Stato. Per il breve regno (poco più di un mese), è anche detto “Re di Maggio”.
Come meta per l’esilio, Umberto II scelse il Portogallo del regime dittatoriale di Salazar, risiedendo dapprima a Sintra (ospite a Villa “Bela Vista”) e, dopo un breve intermezzo, a Cascais (nella residenza di proprietà chiamata “Villa Italia”). Le nazioni confinanti l’Italia non l’avrebbero infatti accolto, e il re voleva evitare la Spagna dove il dittatore Francisco Franco (reggente della monarchia) era salito al potere anche grazie all’Italia fascista. In Portogallo era stato in esilio anche il trisnonno, il re Carlo Alberto, morto ad Oporto nel 1849.
Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana il 1º gennaio 1948 l’esilio di Umberto II di Savoia acquista forza di legge costituzionale, essendo previsto dal primo capoverso della XIII disposizione finale e transitoria, i cui effetti cesseranno solo nel 2002 a seguito di una legge di revisione costituzionale. In numerose interviste Umberto fece trasparire la sua amara sorpresa per l’esilio che gli fu decretato per legge.
Dopo il 1950 Umberto II di Savoia riprese l’esercizio della sovrana prerogativa e, da allora, emanò numerosi provvedimenti nobiliari sia di grazia sia di giustizia, i cosiddetti “titoli nobiliari umbertini”.
Nel suo quasi quarantennale esilio Umberto II svolse opera di aiuto e sostegno verso gli italiani indiscriminatamente, in occasione di bisogni personali o di eventi drammatici. Si impegnò particolarmente per la causa della Venezia Giulia e dell’Istria, indirizzando numerosi messaggi di vicinanza agli istriani e ai giuliani e criticando il trattato di Osimo.
Tramite suoi rappresentanti fu sempre presente, anche come sponsor, a manifestazioni culturali, patriottiche o sociali. A Cascais ricevette decine di migliaia di persone e a tutti coloro che gli scrivevano rispondeva. Appassionato collezionista, costituì un’importante collezione di cimeli sabaudi. Scrisse un vastissimo volume sulla medaglistica sabauda.
A partire dal 1964 Umberto II subisce una serie di pesanti interventi chirurgici, probabilmente a causa del tumore che dopo lunghe sofferenze sarà la causa della sua morte. Muore a Ginevra alle 15.45 del 18 marzo 1983, in una clinica dove era stato trasferito pochi giorni prima da Londra, in un estremo quanto inutile tentativo di allungargli la vita. Al momento della fine era solo: un’infermiera, entrando nella stanza, si accorse del suo stato e gli prese la mano negli ultimi istanti di vita, mentre il morente Umberto mormorava la parola “Italia”.
Nel suo testamento Umberto lascia al papa la Sindone, che dal 1578 era conservata nel duomo di Torino a titolo di deposito. Trattandosi di una delle tante proprietà pervenute ai Savoia prima della proclamazione del Regno d’Italia, essa è stata esclusa dall’avocazione a favore dello Stato sancita dal secondo capoverso della XIII disposizione finale e transitoria della Costituzione.
Le spoglie dell’ultimo sovrano d’Italia riposano, per suo espresso volere, nell’abbazia di Altacomba a fianco di quelle del re Carlo Felice, nel dipartimento francese della Savoia dalla quale casa Savoia ha tratto le sue origini storiche.
Umberto II ha voluto che, nella propria bara, fosse riposto il sigillo reale, grosso timbro che si trasmette di generazione in generazione quale simbolo visibile della legittimità nella linea dinastica e simbolo del gran maestro degli ordini cavallereschi di casa Savoia. In tal modo, si ritiene che egli abbia inteso distinguere i suoi “eredi dinastici” da quelli “civili”, impedendo a questi ultimi di entrare in possesso del simbolo che avrebbe potuto ingenerare, nella pubblica opinione, la convinzione della loro qualità di “successori dinastici”.
Al suo funerale, disertato dalle autorità italiane (con l’eccezione di Maurizio Moreno, console generale d’Italia a Lione, in rappresentanza del governo), parteciparono 10.000 italiani che raggiunsero l’abbazia di Altacomba vicino ad Aix-les-Bains in Savoia.
La Rai non trasmise la diretta televisiva. Alle esequie erano presenti, oltre a membri di casa Savoia: Juan Carlos I di Spagna e Sofia di Grecia, Baldovino e Fabiola del Belgio, Giovanni di Lussemburgo e Giuseppina Carlotta del Belgio, il principe Ranieri di Monaco col figlio Alberto, il duca di Kent in rappresentanza di Elisabetta II del Regno Unito, i re detronizzati di Bulgaria, Romania e Grecia (Simeone II, Michele I e Costantino II), i rappresentanti delle case d’Asburgo, Borbone, Baviera e di altre case già regnanti. La Santa Sede era rappresentata dal nunzio apostolico a Parigi.
I giocatori della Juventus, nella partita del 20 marzo contro il Pisa, portarono il segno del lutto al braccio: questa fu la sola manifestazione di cordoglio, resa pubblicamente in Italia al re Umberto II.