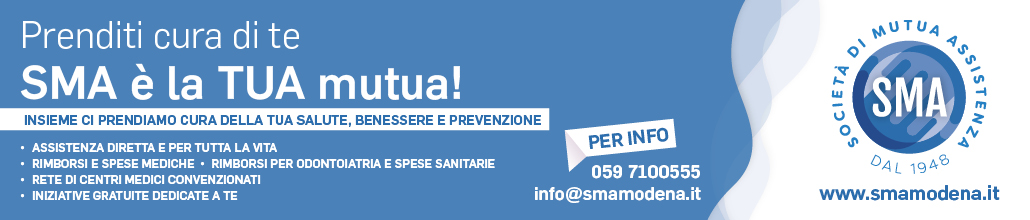Il 27 settembre 1540 l’Ordine dei Gesuiti riceve il proprio statuto da Papa Paolo III.
La Compagnia di Gesù è un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i membri di questo ordine di chierici regolari, detti gesuiti, pospongono al loro nome la sigla S.I.
L’ordine fu fondato da Ignazio di Loyola che, con alcuni compagni, a Parigi nel 1534 fece voto di predicare in Terra Santa (progetto abbandonato nel 1537) e di porsi agli ordini del papa: il programma di Ignazio fu approvato da papa Paolo III con la bolla Regimini militantis ecclesiae (27 settembre 1540).
Espulso da vari paesi europei nella seconda metà del XVIII secolo, l’ordine fu soppresso e dissolto da papa Clemente XIV nel 1773 (la Compagnia sopravvisse però nei territori cattolici della Russia, perché la zarina Caterina II non concesse l’exequatur al decreto papale di soppressione); fu ricostituito da papa Pio VII nel 1814.
I gesuiti osservano il voto di totale obbedienza al papa e sono particolarmente impegnati nelle missioni e nell’educazione. Il 13 marzo 2013 è stato eletto papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio), il primo pontefice gesuita.
Íñigo López de Loyola nacque, ultimo di tredici figli, attorno al 1491 da una nobile famiglia basca. A tredici anni fu inviato ad Arévalo come paggio del primo tesoriere di Ferdinando II d’Aragona, Juan Velázquez de Cuéllar, e nel 1517 si arruolò nelle truppe del viceré di Navarra, il duca di Nájera Antonio Manrique de Lara, prendendo parte alle guerre di Carlo V contro Francesco I: durante la difesa di Pamplona, assediata dai francesi, fu colpito da una palla di cannone che gli sfracellò la gamba destra e gli ferì la sinistra, costringendolo a claudicare per tutta la vita.
Durante il periodo di convalescenza nel castello di Loyola, che trascorse leggendo la Vita Christi di Ludolfo di Sassonia e la Leggenda aurea di Jacopo da Varagine, maturarono in lui i germi di una profonda crisi spirituale e si convertì: deciso a recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme, sostò presso il monastero benedettino di Montserrat e, trascorsa una notte in preghiera davanti all’immagine della Madonna nera, depose le sue armi ai piedi dell’immagine sacra e prese l’abito e il bastone da pellegrino. Si diresse quindi a Manresa, dove rimase un anno vivendo ricche esperienze interiori: lesse l’Imitazione di Cristo, testo a cui rimase legato per tutta la vita e cominciò a cercare la pace dell’anima attraverso opere straordinarie di penitenza, poi ritrovò la serenità d’animo e attenuò le sue austerità; durante il soggiorno a Manresa cominciarono a prendere forma gli elementi essenziali dei suoi Esercizi spirituali.
Nel 1523 raggiunse Venezia e si imbarcò per Gerusalemme, dove visitò i luoghi santi. Dovette però abbandonare il progetto di stabilirsi in Palestina per il divieto di soggiorno impostogli dai frati francescani dalla Custodia di Terra Santa. Tornato in Spagna con il desiderio di abbracciare il sacerdozio, riprese gli studi a Barcellona, poi presso l’università di Alcalá dove, per il suo misticismo, fu sospettato di essere un alumbrado e fu tenuto in carcere dall’Inquisizione per quarantadue giorni. Si trasferì quindi a Salamanca e poi, per completare la sua formazione, a Parigi, dove arrivò il 2 febbraio 1528.
A Parigi Íñigo cominciò a farsi chiamare Ignazio, che pensava essere una variante del suo nome: in realtà, Íñigo era la forma basca del nome Innico o Enecone, che gli era stato imposto in omaggio a sant’Enecone, abate benedettino di Oña, il cui culto era particolarmente sentito nella sua terra.
Iscrittosi al Collège Saint-Barbe, ebbe come compagni di stanza Pierre Favre, figlio di un umile pastore della Savoia, e Francesco Saverio, di nobile famiglia della Navarra; nel 1533 incontrò Diego Laínez e Alfonso Salmerón, anch’essi spagnoli e provenienti dall’università di Alcalá che, essendo appena giunti in Francia e non conoscendo bene la lingua del posto, si legarono molto a lui. Nel 1534 si unirono al gruppo di compagni di Ignazio il portoghese Simão Rodrigues e lo spagnolo Nicolás Bobadilla, che aveva studiato teologia e filosofia ad Alcalá e Valladolid.
Favre fu ordinato sacerdote agli inizi del 1534. Il 15 agosto 1534 (festa dell’Assunzione di Maria), nella cappella della Vergine a Montmartre (sorta sul luogo tradizionale del martirio di san Dionigi e dei suoi compagni), Favre celebrò l’eucaristia e, prima della comunione, accolse i voti di Ignazio, Saverio, Laínez, Salmerón, Rodrigues e Bobadilla; poi pronunciò i suoi voti e si comunicò. Non si conosce il testo della formula del voto emesso dai compagni, ma doveva trattarsi di quelli di povertà, di recarsi a Gerusalemme e mettersi a disposizione del papa (la promessa di castità era implicita, essendo tutti aspiranti al sacerdozio).
Prima di partire da Parigi per Gerusalemme, ai sei si unirono tre francesi, Claude Jay, Paschase Broët e Jean Codure, e giunti a Venezia per imbarcarsi si aggregò alla comunità anche il prete andaluso Diego Hoces.
Poiché imbarcarsi per la Palestina in inverno non era possibile, i compagni trascorsero l’attesa lavorando gratuitamente presso gli ospedali veneziani degli Incurabili e dei Santi Giovanni e Paolo; si recarono poi a Roma, dove furono accolti favorevolmente da papa Paolo III, che benedisse il loro pellegrinaggio, donò loro del denaro per pagarsi il viaggio e diede a tutti il permesso di farsi ordinare sacerdoti da un vescovo a loro scelta (fino ad allora, solo Favre e Hoces erano preti).
I compagni emisero i voti di povertà e castità nelle mani di Girolamo Verallo, legato pontificio a Venezia; Ignazio (assieme a Saverio, Laínez, Rodrigues, Bobadilla e Codure) fu ordinato sacerdote il 24 giugno 1537 da Vincenzo Nigusanti, vescovo di Arbe in Dalmazia, nella cappella privata della residenza del presule a Venezia. Subito dopo si divisero in gruppi di due o tre individui e si stabilirono in diverse città (Verona, Vicenza, Treviso, Monselice, Bassano) dove si dedicarono alla predicazione per le strade, vivendo di elemosina e alloggiando dove capitava. Avvicinandosi l’inverno, il gruppo si riunì a Vicenza e, preso atto che il desiderato viaggio a Gerusalemme non era fattibile, decisero di stabilirsi in nuove città (soprattutto universitarie, dove avrebbero potuto trovare nuovi giovani aspiranti a unirsi alla comunità).
Prima di lasciarsi, decisero di chiamarsi Compagnia di Gesù, perché Cristo era il loro unico modello, colui a cui essi dedicavano tutta la vita. Il termine compagnia era molto utilizzato nel nome delle confraternite e di altre società ecclesiastiche: diversamente da quanto tradizionalmente si ritiene (anche gli storici gesuiti Jerónimo Nadal e Juan de Polanco sposarono l’idea) la parola “compagnia” non fu adottata per la sua connotazione militare.
Nel novembre del 1537, Ignazio, Favre e Laínez si recarono nuovamente a Roma. Secondo la tradizione, presso La Storta, a nove miglia dalla città, Ignazio ebbe una delle sue più celebri esperienze mistiche: ricevette la visione di Dio Padre insieme a Cristo con la Croce, che lo invitavano a essere loro servo e gli assicuravano sostegno a Roma. Paolo III accolse calorosamente i gesuiti e diede a Favre e Laínez l’incarico di insegnare teologia e sacre scritture alla Sapienza. I tre divennero celebri dando gli Esercizi spirituali, predicando per l’avvento e la quaresima in Trinità dei Monti e per le strade e assistendo la popolazione colpita dalla carestia.
Ignazio e i compagni cominciarono a essere richiesti dagli alti prelati della Curia che diedero loro incarichi importanti (il cardinale Carafa affidò loro la riforma di alcuni monasteri). Crescendo la loro importanza, nei primi mesi del 1539 i membri della Compagnia si riunirono spesso per discutere del futuro della comunità e il 15 aprile, durante una messa presieduta da Favre, furono interrogati sulla loro disponibilità ad andare a costituire un ordine e a farne parte. Le loro discussioni si protrassero fino al 24 giugno e portarono alla stesura dei “Cinque capitoli”, il testo base della Formula instituti.
La Formula, approvata da Paolo III il 3 settembre 1539, conteneva i principali fondamenti della Compagnia: il carattere apostolico, il fine di far progredire gli uomini nella fede e nella cultura religiosa, la povertà, l’obbedienza alla Santa Sede e al preposito, l’abolizione degli uffici corali, la promessa di recarsi ovunque il papa avesse indicato.
Il testo fu sottoposto all’esame di una commissione di cardinali. Gasparo Contarini appoggiò incondizionatamente la formula; Girolamo Ghinucci, vedendo nell’abolizione del coro una concessione al luteranesimo, manifestò forti riserve; Bartolomeo Guidiccioni, ostile al clero regolare, cercò di ostacolare la nascita dell’ordine. Alla fine la commissione diede il suo parere favorevole, ma Guidiccioni concesse il suo voto favorevole solo in cambio dell’imposizione alla Compagnia di un limite massimo di sessanta membri (all’epoca, i gesuiti erano circa venti). Papa Paolo III concesse l’approvazione pontificia con la bolla Regimini militantis Ecclesiae del 27 settembre 1540.
La Compagnia di Gesù divenne un ordine riconosciuto dalla legge canonica: Ignazio fu eletto all’unanimità preposito generale e il 22 aprile 1541, nella basilica di San Paolo fuori le mura, il fondatore e i suoi compagni pronunciarono i loro voti solenni. Il limite di sessanta membri fu abolito nel 1544 (bolla Iniunctum nobis) e il 21 luglio 1550, con la bolla Exposcit debitum, l’ordine fu confermato da papa Giulio III.