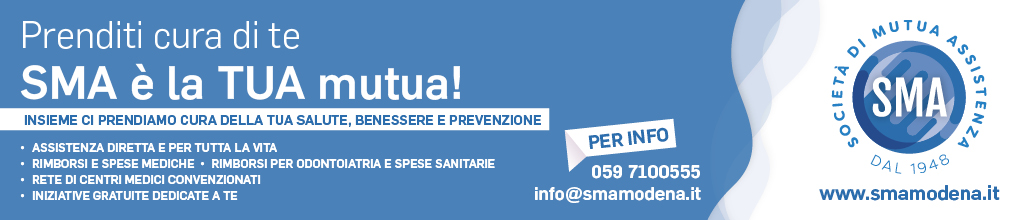Il 4 marzo 1848 Carlo Alberto emana lo Statuto Albertino.
Lo Statuto del Regno o Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia del 4 marzo 1848 (noto come Statuto Albertino dal nome del re che lo promulgò, Carlo Alberto di Savoia), fu la costituzione adottata dal Regno sardo-piemontese il 4 marzo 1848 a Torino.
Nel preambolo autografo dello stesso Carlo Alberto viene definito come «Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia sabauda». Il 17 marzo 1861, con la fondazione del Regno d’Italia, divenne la carta fondamentale della nuova Italia unita e rimase formalmente tale, pur con modifiche, fino al biennio 1944-1946 quando, con successivi decreti legislativi, fu adottato un regime costituzionale transitorio, valido fino all’entrata in vigore della Costituzione, il 1º gennaio 1948.
Lo Statuto Albertino, in quanto costituzione flessibile, poteva essere modificato o integrato con legge adottata secondo la procedura ordinaria. Le leggi costituzionali infatti, sono presenti nell’ordinamento italiano solo a partire dalla Costituzione repubblicana del 1948 che è rigida.
In seguito ai moti promossi dalle classi borghesi, cui talora partecipò anche l’aristocrazia, nelle principali città del Regno di Sardegna, Carlo Alberto prese una serie di provvedimenti di stampo liberale: nel 1837 emanò un codice civile, a cui seguì un codice penale nel 1839; nel 1847 riformò la disciplina della censura (imposta da Vittorio Emanuele I), permettendo la pubblicazione di giornali politici; creò, poi, una Corte di Revisione (ossia di Cassazione) per assicurare una certa uniformità della giurisdizione nello Stato, riducendo le competenze dei vecchi senati e pubblicando il codice di procedura penale basato sulla pubblicità del dibattimento. Su ispirazione austriaca, aggiornò anche la composizione del Consiglio di Stato, creato nel 1831, che sarebbe stato formato da due rappresentanti per ogni Divisione territoriale fra i Consiglieri delle Province componenti la Divisione, consiglieri provinciali che a loro volta erano scelti fra quelli comunali.
Gli avvenimenti dei primi mesi del 1848 sembravano comunque ancora confermare la resistenza ad ipotesi costituzionali, Carlo Alberto rifiutò in maniera netta l’idea di concedere una Costituzione e ne parlò al Consiglio di Conferenza del 13 gennaio 1848, prendendo in considerazione, secondo il Cognasso, anche una possibile abdicazione al trono del Regno di Sardegna. Il 30 gennaio 1848 il Corpo Decurionale di Torino, riunitosi per discutere l’istituzione della Guardia Nazionale, apprendeva la notizia della concessione a Napoli, il giorno prima, della Costituzione da parte di Ferdinando II delle Due Sicilie. Il Corpo decise seduta stante di richiedere al Re una Costituzione anche per il Regno di Sardegna: Carlo Alberto in fretta e furia fece redigere una dichiarazione di principi che saranno alla base dello Statuto (termine ripreso dalla tradizione di Amedeo VIII di Savoia) e che vennero proclamati al popolo l’8 febbraio 1848, tre giorni prima che il Granduca di Toscana prendesse la stessa decisione ed un mese prima di Pio IX. Tali basi, indicate in quattordici punti, vennero formalmente concesse per la benevola generosità del sovrano, il quale unì al paternalismo una velata minaccia di non procedere oltre se i “popoli” non fossero stati “degni” delle sue manifestazioni di apertura. In questo modo, comunque, Carlo Alberto aveva tranquillizzato tanto i liberali quanto i democratici.
Il Consiglio di Conferenza, incaricato di redigere lo Statuto, ebbe come principale obiettivo quello di individuare, tra i modelli costituzionali europei, quello maggiormente congeniale al Regno di Sardegna, e che producesse il minor cambiamento possibile all’interno degli assetti istituzionali. Questo modello venne individuato nella Costituzione orleanista del 1830 e in quella belga del 1831. Pochi giorni dopo, tra il 23 e il 24 febbraio la Rivoluzione spazzava via da Parigi sia la monarchia sia la Costituzione. La sommossa parigina, che portò poi al potere Luigi Bonaparte, eccitò gli animi anche in Italia e fece balenare nella mente dei liberali più accesi e rivoluzionari l’idea di una Repubblica tale che quindi la promessa delle “basi” di Carlo Alberto sembrava ormai troppo limitata. Tuttavia ciò non mutò le posizioni del Re che il 4 marzo promulgò lo Statuto.
Nel 1861, con la nascita del Regno d’Italia, lo Statuto venne applicato in tutto il Regno. La natura flessibile dello Statuto garantì, sino agli anni venti, un’evoluzione parlamentare del sistema politico senza rendere necessarie modifiche effettive al testo originale: gradualmente i Governi cessarono di dipendere dalla fiducia del Re, mentre divenne necessaria quella del Parlamento. Anche il Senato perse importanza di fronte alla Camera dei deputati, il Re tuttavia mantenne una particolare influenza sulla politica estera e su quella militare: basti pensare che la tradizione voleva che i ministri della Guerra e della Marina (provenienti dai ranghi militari) fossero designati dal Re al Presidente del Consiglio dei ministri.
L’evoluzione parlamentarista dello Statuto cessò completamente con l’avvento della dittatura fascista. Nel corso degli anni lo Statuto venne gradualmente messo da parte attraverso leggi ordinarie contrarie allo spirito dello Statuto stesso: si pensi alla fine della libertà d’espressione, l’istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello stato o alle leggi razziali.
Dopo la caduta del fascismo, crebbe il consenso che – qualunque forma istituzionale fosse stata scelta per l’ordinamento italiano – lo Statuto dovesse ormai considerarsi superato. Con il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 venne stabilito che Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.
Il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 146 istituì la Consulta nazionale, assemblea non elettiva di nomina governativa il cui scopo era fornire pareri sui provvedimenti legislativi che venissero ad essa sottoposti dal Governo; in pratica, il primo embrione della Corte costituzionale. Infine il d.l.l. 16 marzo 1946, n. 98 sancì le elezioni per l’Assemblea Costituente. Con la nascita della Repubblica Italiana e l’entrata in vigore della costituzione della Repubblica Italiana il 1º gennaio 1948, lo statuto fu definitivamente superato.