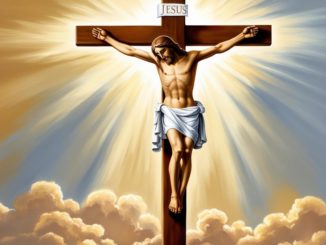09/02/2009
h.12.20
Nel contesto di una conversazione con il critico del New York Times Mel Gussow, Harold Pinter disse “Capisco l’interesse per me come autore, ma sono più interessato a me stesso come cittadino. Continuiamo a dire che viviamo in paesi liberi, ma sarebbe molto meglio se imparassimo a parlare liberamente e ad assumerci la responsabilità di dire esattamente quello che pensiamo”.
Aperto sostenitore dei diritti civili e della lotta contro la repressione in tutti i paesi in cui veniva praticata, il premio Nobel per la letteratura, recentemente scomparso, ha esplicitato il suo pensiero politico nei tre brevi drammi Il bicchiere della staffa, Il linguaggio della montagna, Il nuovo ordine mondiale.
Con la produzione di Fondazione Teatro Due il regista Massimiliano Farau li mette ora in scena insieme al grande atto unico, che funge da premessa ideale e simbolica, Catastrofe di Samuel Beckett, autore ammirato da Pinter per la sua straordinaria intelligenza politica.
Debutterà in prima nazionale il 13 febbraio alle 21.00 a Teatro Due questa suite di brevi drammi politici interpretata da Paolo Bocelli, Federica Bognetti, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo, Davide Lora, Massimiliano Sbarsi, Antonio Tintis, Nanni Tormen e con Lorenzo Ghirardi e Riccardo Monaco che si alternano nel ruolo di Nicky, scene di Fabiana Di Marco, costumi di Gianluca Falaschi e luci di Pasquale Mari. Le repliche proseguiranno fino al 4 marzo 2009.
Sconvolgenti per la loro attualità, i drammi di Pinter e l’atto unico di Beckett, oltre al palese tema dell’oppressione politica, della minaccia e della tortura, scoprono qualcosa di più sottile e profondamente teatrale: la falsificazione dell’identità dell’altro nel rapporto dialogico, sino alla riduzione al silenzio, e l’umiliazione. Temi che giungono a perenne monito, anche in un momento pieno di ottimismo come questo in cui il neo presidente degli Stati Uniti Barak Obama con il suo rifiuto al ricorso alla tortura sembra aver riaperto la strada per il ritorno alla Costituzione; “Chi userà la forza contro la democrazia, sarà sconfitto” afferma Obama.
Premessa a questi tre brevi plays, è Catastrofe di Samuel Beckett, brevissimo e poderoso atto unico dove l’autore sceglie il mondo del teatro e le sue gerarchie come metafora di ogni genere di coercizione e umiliazione.
Un regista e la sua assistente preparano un attore per la scena finale di un dramma. L’attore è completamente inerte; il suo corpo, affetto da un penoso processo degenerativo delle ossa e dei tessuti (è trucco di scena? È realtà?) si assoggetta senza resistenza alla meticolosa quanto spietata manipolazione. Catastrofe, commissionato a Samuel Beckett dal Festival di Avignone nel 1983, con il preciso scopo di sollecitare l’attenzione dei paesi occidentali sul caso di Vàclav Havel, che di lì a pochi anni sarebbe diventato presidente della Repubblica Ceca, ma che all’epoca era un intellettuale dissidente tenuto in carcere a Praga, è considerato da Pinter un esempio insuperabile di teatro politico.
Il bicchiere della staffa, Il linguaggio della montagna, Il nuovo ordine mondiale, scritti da Pinter fra il 1985 e il 1991, condensano alcuni dei motivi ricorrenti del suo teatro più recente: la violenza sul dissenziente, l’uso della parola come strumento di intimidazione o di tortura, la manipolazione dell’altro attraverso una sistematica contraffazione del linguaggio.
Per usare le parole pronunciate da Horace Engdal, presidente dell’Accademia di Svezia, nel discorso che ha accompagnato la consegna a Pinter del premio Nobel per la letteratura nel 2005, con questi fulminanti atti unici il nostro autore “ci costringe ad entrare nei luoghi chiusi dell’oppressione”.
Camere della tortura, misteriosi reclusori in cui corridoi segreti o asettiche sale colloquio diventano luoghi di sevizia psicologica: l’ambientazione è sempre imprecisata e possiamo immaginare lontani regimi dittatoriali, ma anche sentire che tutto ciò potrebbe avvenire dietro l’angolo o a casa nostra.
Come ha scritto il critico Michael Billington, “Pinter è stato sempre ossessionato dal modo in cui usiamo il linguaggio per mascherare bisogni primari. La differenza nei sui testi più recenti consiste non solo nel fatto che essi si spostano nell’arena politica, ma che alla cortina fumogena della parola fanno da contrappunto immagini scioccanti e inquietanti di tortura, castigo e morte”.