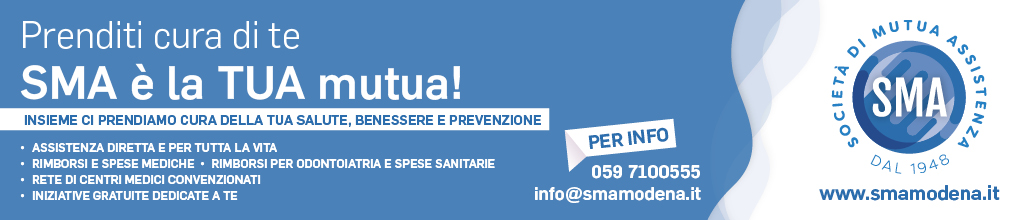Il 17 novembre 1983 viene fondato l’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.
L’EZLN (abbreviazione di Ejército Zapatista de Liberación Nacional) è un movimento armato clandestino, di stampo anticapitalista, libertario e indigenista, attivo in Chiapas, lo Stato più meridionale ed uno dei più poveri del Messico.
Il più famoso portavoce dell’EZLN è stato il subcomandante Marcos, ritiratosi volontariamente dal suo ruolo di portavoce nel maggio 2014. Uno dei loro motti è Democracia, justicia y libertad.
L’EZLN si formò il 17 novembre 1983, ricorrenza tutt’oggi festeggiata. I suoi fondatori provenivano in parte da altri gruppi, tra cui alcuni combattenti e altri pacifici. Hanno fatto irruzione nel panorama nazionale e internazionale il 1º gennaio 1994, in concomitanza con l’entrata in vigore del NAFTA (North American Free Trade Agreement), noto in spagnolo come TLC (Tractado de Libre Comercio), un accordo tra Messico, USA e Canada per l’agevolazione delle attività commerciali tra questi paesi.
Hanno più avanti dichiarato che il loro motto fosse “Aquí estamos!” (siamo ancora qui) riferito a una globalizzazione che, a detta loro, imponesse nuove regole non tenenti conto delle loro necessità più basilari. I combattenti indigeni, indossando passamontagna e fazzoletti per coprire il volto, hanno preso quel giorno cinque comuni del Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Huixtan e Chanal; avrebbero voluto prendere anche Tuxtla Gutiérrez, ma non la conoscevano abbastanza).
Dal comune di San Cristóbal, il subcomandante Marcos ha letto la prima dichiarazione della Selva Lacandona, nella quale dichiaravano guerra al governo del Messico e annunciavano libertà, giustizia e democrazia per tutti i messicani che secondo loro ne avevano bisogno. È stato anche preso prigioniero di guerra l’ex-governatore del Chiapas, il generale Abasolón Castellanos Domínguez; quest’ultimo è stato in seguito giudicato e condannato da un simbolico tribunale indigeno, e in seguito rilasciato privo di lesioni corporali.
Comunque, il giorno successivo sono fuggiti dai centri urbani chiapanechi, mentre l’esercito riprendeva il controllo . Vi furono ingenti manifestazion da parte della popolazione civile, che chiedeva a entrambe le parti un cessate il fuoco, schierandosi però più dalla parte dell’EZLN. Dopo dodici giorni di combattimenti il presidente Carlos Salinas de Gortari, al suo ultimo anno di mandato, ha accettato la proposta dell’EZLN di un dialogo con la mediazione della diocesi di San Cristóbal.
Le trattative durarono tre anni, con alti, bassi e interruzioni. Terminarono con la firma degli accordi di San Andrés, secondo i quali il governo avrebbe dovuto modificare la costituzione inserendo il riconoscimento dei popoli e delle culture indigene, oltre a un’autonomia legislativa. Una commissione di deputati di vari partiti politici, chiamata COCOPA, ha modificato leggermente il testo dell’accordo con il consenso dell’EZLN. Il governo del Chiapas, ora guidato dal presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, tuttavia, non ha però rispettato gli accordi e ha rafforzato la presenza militare nelle zone di influenza degli zapatisti. A ciò è seguito un silenzio dell’EZLN durato tre anni.
Sono state denunciate molte violazioni del cessate il fuoco e degli accordi da parte del governo chiapaneco, mentre il governo federale ha sempre cercato di non rimanere coinvolto, definendolo un problema locale. L’esercito e i paramilitari hanno compiuto vari atti di violenza, il più grave dei quali è senza dubbio la Mattanza di Acteal. In tale occasione i paramilitari attaccarono una comunità non zapatista e nonviolenta, massacrando 45 persone, tra le quali vi erano 4 donne incinte che furono sventrate con i machete.
Le vittime, uccise senza che nessuna autorità pubblica muovesse un dito, non erano zapatisti. Facevano parte di un’associazione pacifista, Las Abejas, nata cinque anni prima. Alla vigilia di Natale erano riuniti in chiesa a pregare. Dopo la matanza del 22 dicembre del 1997 il governo messicano accusò 20 indigeni, che dopo aver passato undici anni di prigione vennero messi in libertà per irregolarità nel processo. La storia del massacro è una storia di impunità e coperture, soprattutto dei vertici dell’esercito veri mandanti della violenza.