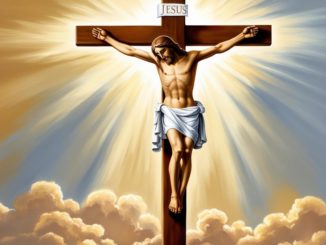16/09/2014
ACCADDE OGGI: Il 6 giugno del 1982 l’IDF (Israeli Defence Force) entrava nel territorio del Libano dando il via all’operazione Pace in Galilea. Obiettivo dell’azione era di porre in sicurezza “l’intera popolazione civile della Galilea fuori dal tiro dei terroristi che hanno concentrato la loro base ed il loro quartier generale in Libano”, lacerato ormai da 7 anni di guerra civile. Dopo due mesi e mezzo di scontri il 31 Agosto circa 11.500 combattenti palestinesi e 2.700 siriani, sotto gli occhi della forza multinazionale di pace che comprendeva truppe americane, francesi ed italiane, si ritirarono dal Libano. Il 14 settembre una bomba comandata a distanza esplose nel quartier generale del presidente libanese Bashir Gemayel a Beirut uccidendolo. Gemayel, eletto da poco e comandante della milizia falangista cristiano-maronita sostenuta da Israele, aveva fatto intendere in maniera inconfondibile che in Libano “c’era un popolo di troppo: il popolo palestinese”.
Due giorni dopo la sua morte e a poche ore dall’entrata delle forze Israeliane a Beirut Ovest, miliziani falangisti iniziarono a massacrare i profughi palestinesi presenti nei campi di Sabra e Chatila, comprese donne e bambini. Le donne, disse un falangista all’equipaggio di un carro armato israeliano il 17 Settembre, “partoriranno terroristi e quando cresceranno i bambini diventeranno terroristi”, e per questo non potevano essere risparmiate. I falangisti marciarono sui campi su ordine dei comandanti dell’esercito Israeliano per snidarvi eventuali terroristi rimastivi, ma con l’intento implicito di eseguire gli ordini di Gemayel e di vendicarlo. L’esercito della stella di Davide, pur sapendo quanto stava avvenendo, non intervenne, e circondò invece i campi per impedire la fuga dei profughi.
Dopo 48 ore i falangisti se ne andarono ed uno dei primi ad entrare nei campi fu il giornalista britannico Robert Fisk. Questo è quanto vide a Chatila: “Quello che trovammo nel campo palestinese di Shatila alle dieci di mattina del 18 settembre 1982 non era indescrivibile, ma sarebbe stato più facile da raccontare nella fredda prosa di un esame medico. C’erano già stati massacri in Libano, ma raramente di quelle proporzioni e mai sotto gli occhi di un esercito regolare e presumibilmente disciplinato. Nell’odio e nel panico della battaglia, in quel paese erano state uccise decine di migliaia di persone. Ma quei civili, a centinaia, erano tutti disarmati. Era stato uno sterminio di massa, un’atrocità, un episodio – con quanta facilità usavamo la parola “episodio” in Libano – che andava ben oltre quella che in altre circostanze gli israeliani avrebbero definito una strage terroristica. Era stato un crimine di guerra”.
Parole quelle di Fisk che avrebbero potuto essere tratte da un resoconto sugli eccidi commessi dalle SS in tutta Europa durante l’Olocausto e la persecuzione degli ebrei 40 anni prima. Le vittime stimate di quello che la risoluzione 37/123 dell’Assemblea Generale dell’ONU definirà successivamente un “atto di genocidio” varia, a seconda delle fonti, da 450 a 3.500.
Israele in seguito condannò il massacro pur negando ogni responsabilità diretta. Il 29 Settembre una forza di pace delle Nazioni Unite ritornò in Libano per evitare ulteriori spargimenti di sangue. I responsabili delle stragi rimasero ufficialmente impuniti. Il ministro della difesa del governo Israeliano Sharon fu ritenuto personalmente responsabile per aver permesso ai miliziani di fare il loro ingresso nei campi e venne costretto a dimettersi. Nel 2001 diventerà Primo ministro d’Israele.
Alessandro Guardamagna