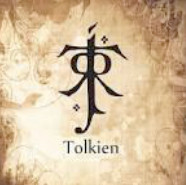
01/09/2014
ACCADDE OGGI: 2 settembre 1973, muore Tolkien autore de Il Signore degli Anelli.
Il 2 settembre 1973 moriva a Bornemouth in Inghilterra John Ronald Reul Tolkien, ex-docente di Letteratura Anglosassone e Medievale e autore de Lo Hobbit, fiaba che scrisse per il figlio Christopher nel 1937 e che finirà per costituire la base su cui si svilupperà il futuro romanzo, divenuto poi un vero e proprio best seller, Il Signore degli Anelli (The Lord of the Rings).
Pubblicato in forma di trilogia fra il 1954 e nel 1955, l’opera s’incentra sulle avventure dell’Hobbit Frodo Baggins che nella Terra di Mezzo si ritrova in possesso di un anello – ereditato dal cugino Bilbo protagonista de lo Hobbit che l’aveva trovato casualmente. L’anello dona l’invisibilità e un potere smisurato e Frodo, consigliato dal mago Gandalf, dovrà distruggere il talismano per salvare il mondo dalle mire malvagie di Sauron, signore e creatore dell’anello che tenterà in tutti i modi di riprenderselo per esercitare il dominio assoluto su cose e esseri viventi.
Tolkien nacque il 3 gennaio 1892 a Blomfontein, in Sud Africa, da genitori Inglesi. Rimasto orfano di padre a quattro anni, ritornerà in Inghilterra con la madre e il fratello Arthur. Nel 1904 alla morte della madre, da cui aveva ereditato una forte passione per la lettura e le favole, i due fratelli saranno affidati alle cure di un sacerdote cattolico, padre Morgan. Laureatosi ad Oxford in letteratura medievale Inglese nel 1915, si arruolò come ufficiale nell’11° battaglione dei Lancashire Fusiliers e parteciperà sul fronte occidentale all’offensiva della Somme nel Luglio del 1916. Sarà proprio l’esperienza traumatica della guerra, dove il giovane Tolkien perderà tutti gli amici più cari, a segnarlo profondamente, ma anche a sprigionare la sua creatività, come forma di catarsi ai traumi provati, e a vivificare l’immaginario tolkieniano. Nell’invisibilità dell’anello e in quella dei Nazgûl leggiamo lo sgomento per un nemico invisibile che i soldati della Grande Guerra non riuscivano ad individuare oltre il parapetto della trincea, e che, nelle fugaci apparizioni, spesso si presentava evanescente come uno spettro. La desolazione di Mordor rievoca molto da vicino quella della terra devastata da continui bombardamenti, mentre nei volti esanimi che riaffiorano dalle Paludi Morte – “They lie in all the pools, pale faces, deep deep under the dark water… But all foul, all rotting, all dead.” – si coglie una chiara immagine dei corpi in decomposizione abbandonati nella terra di nessuno.
Più in generale nel senso di solitudine di Frodo tornato alla vita della Contea traspare l’incomunicabilità di chi ha vissuto un’esperienza troppo sconvolgente per poterla trasmettere e, consapevole che niente sarà più come prima, esprime un richiamo al venir meno del senso di sicurezza, dell’ottimismo nel progresso e di quei valori tradizionali del pensiero ottocentesco che il cataclisma della Grande Guerra aveva spazzato via per ridare all’uomo del XX secolo un società basata sulla labilità, dove le capacità, il coraggio e la dedizione non potevano essere considerati sufficienti a assicurare il successo, così come in guerra non erano bastati a garantire la sopravvivenza di milioni di uomini spinti da tali ideali a partecipare al conflitto.
Partendo da tali esperienze e capovolgimenti culturali Tolkien ricostruì una cosmogonia le cui radici affondano principalmente nei miti celtici e germanici, nella storia e leggende dell’Europa dell’alto medioevo, rielaborate con grande capacità e competenza linguistica. Ricreò così un mondo popolato da creature fantastiche e del tutto verosimili, dotate di una propria lingua e cultura, in un contesto di grande originalità il cui limite principale – una certa stereotipizzazione dei personaggi, in particolare quelli femminili, con l’unica eccezione di Smeagol-Gollum – non inficia il valore ultimo dell’opera.
Le opere di Tolkien, fra cui oltre a quelle citate ricordiamo il Silmarillion e i Racconti Incompiuti di Numenor e della Terra di Mezzo pubblicati postumi, hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare del XX secolo, nella letteratura e nella cinematografia.
Alessandro Guardamagna



















